Succede spesso in molti incontri con amici e anche con profani del settore, che a un certo punto della conversazione spunti la frase, generalmente definitiva sull’argomento: “Eh, manca un’idea di città …, una visione …”. Ed è facile convenire sul punto: si ritiene anzi di aver toccato “il” punto.
Ma che cos’è l’Idea-di-città?
Sarebbe, se non intendo male, un’idea totalizzante che prefigura, in un colpo solo, sia lo spazio che il tempo di questo nuovo spazio. Il tempo è infatti il fattore più importante nell’avere questa idea di città. Si deve trattare infatti di un tempo piuttosto lungo (almeno 20 o 30 anni). Non si può dire di avere un’Idea-di-città per i prossimi 12 mesi. Occorre onestamente darsi un orizzonte più lungo.
Ma perché dovremmo avere bisogno di questa Idea-di-città? Perché diamo valore a questo concetto? Non siamo forse prigionieri di una sorta di vizio di origine? Di un vizio demiurgico? Non ci lasciamo sempre abbindolare dal “canto delle sirene”? L’architetto come un Dio più piccolo, capace di prefigurare prima e di figurare poi lo sviluppo di una città nei prossimi 30 anni? In questo caso il pianificatore, il politico, l’urbanista sono molto simili: difficile distinguere, al di là della tecnicalità che l’urbanista apporterà successivamente, una differenza ontologica tra queste figure. L’urbanista partecipa spesso e fin dalle prime battute alle discussioni sul destino della città.
E’ ancora valido questo concetto, questo paradigma? E’ ancora utile, ancora fertile? Negli ultimi anni è servito? O, domanda scandalosa: è mai servito nella storia della città?
Lo strumento tecnico di questa volontà demiurgica è il PRG. Le varianti sono l’indicatore sintetico che questa volontà si è scontrata con la realtà, con le sue dinamiche, con i suoi tempi …
Le varianti sono un indicatore della rigidità del PRG. Si dirà che lo strumento è ancora valido e che è stato usato male. Può essere. Ma allora dobbiamo ammettere che abbiamo avuto una schiera di amministratori-urbanisti di pessima levatura negli ultimi anni. O lo strumento non è perfettamente adeguato o l’artigiano non è capace ad usarlo. O un mix, certo. Ma bisognerebbe fare una riflessione più radicale sul tema.
Bisognerebbe impostare una vera e profonda ricerca storica per vedere quanto i PRG sono stati modificati nella storia della città, quando e perché. Non parlo solo degli ultimi anni. Io dico: risaliamo pure indietro nella storia della città, anche molto indietro, e vediamo quando e dove e quanto si è dovuta modificare rispetto a una “volontà di piano”. Una ricerca universitaria seria, con una gran mole di dati, di date, di esempi, di esempi diversi su scale diverse. E contestualizzando anche le dinamiche e le decisioni in funzione del valore di alcuni concetti. Non possiamo nasconderci per esempio (ne cito uno per tutti), che il tempo aveva un valore e paradossalmente una “durata” diversa anche solo 50 anni fa rispetto a oggi.
Onestamente, siamo ancora in grado di immaginare lo sviluppo di una città nei prossimi 30 anni? E la domanda ancora più scandalosa: siamo mai stati in grado? O il nostro rito del PRG, con la liturgia dei Piani Particolareggiati, si è spento nel tempo, si è infranto contro le resistenze delle logiche insediative, di volontà che hanno scavalcato il potere e la competenza locale?
O allora le nostre città sono andate avanti nella loro storia, malgrado il PRG, malgrado il mito dell’Idea-di-città?
La città si sarebbe allora adeguata invece ai vari accadimenti puntuali (nello spazio e nel tempo), che la realtà ha imposto alla città? La città si è modificata a seguito di questi grandi accadimenti (frane, alluvioni, sismi, ma anche ferrovie, autostrade, porti, tunnel, industrie, carceri, caserme, ecc.), qualche volta in maniera fragile, qualche con inerzia (tollerando), qualche volta in maniera anti-fragile.
Forse più che un’Idea-di-città, ci sarebbero state delle grandi idee già localizzate, e il PRG avrebbe cercato di adeguarsi a queste idee di sviluppo. Tra l’altro, come ben sa chi frequenta un po’ la materia, le varianti al PRG passano in Consiglio Comunale, prima di finire sul tavolo dell’urbanista. E dunque l’accoglimento di queste idee di sviluppo (la maggior parte sono idee di sviluppo infrastrutturali o produttive: l’abitazione seguirà), richiede già una valutazione sociale, economica, politica, da parte del potere locale.
La tesi finale è insomma che il rapporto tra il PRG e le Grandi Idee Localizzate (mi si passi provvisoriamente la locuzione), sia stato poco studiato (intendo studiato con un corredo di dati pluridisciplinari e non solo sotto il profilo della Storia della città), e che intuitivamente questo rapporto veda il PRG molto in sofferenza e sempre alla rincorsa della vita.
Autore: bmbarch
Fontivegge
Recentemente il professor Michele Chiuini ha prodotto 4 articoli con cui ha denunciato gli errori di Aldo Rossi a Fontivegge. Possono essere reperiti qui: https://www.perugiatoday.it/…/libero-pensiero…
Ha scritto poi sullo stesso argomento il prof. Paolo Belardi qui: https://www.perugiatoday.it/…/libero-pensiero-perugia… Altri articoli, di singoli architetti o di gruppi sono apparsi su Facebook. L’argomento sembra quindi essere di attualità. Va riconosciuto dunque da subito al prof. Michele Chiuini il merito di aver aperto una discussione sul tema, anche con un un tono franco e con delle argomentazioni di merito. Argomentazioni che mi permetto di contestare a titolo personale, in maniera a-sistematica, come architetto appassionato della materia. Innanzi tutto, bisognerebbe distinguere un po’ più chiaramente quello che è la responsabilità di Aldo Rossi dalla responsabilità della politica e dalla conseguente responsabilità del pianificatore. Stabilire i confini, comprendere qual è il dominio della funzione. Altrimenti la critica vira subito verso la facile polemica. Nell’articolo, invece, vari registri si sovrappongono. Il tema era, nel 1970, rispondere a un bando di concorso in un’area molto complicata per quote e viabilità, e non risolvere tutti i problemi di una parte importante della città. Ma andiamo con ordine, seguendo le affermazioni del Prof. Chiuini.
Chiuini dice: “Gli edifici di Aldo Rossi, a Fontivegge, voltano le spalle alla strada: voltano la schiena a via Mario Angeloni, con il risultato di devitalizzarla. Volgere la schiena degli edifici significa collocare le funzioni di servizio (garage, raccolta rifiuti, scale, ascensori, bagni) sul lato strada e le attività sociali (negozi, ingressi delle abitazioni, vani abitabili, balconi) all’interno dell’isolato”. Ora, a mio avviso l’errore è il considerare le strade tutte uguali, quando non lo sono. E non lo sono per le funzioni che svolgono, e anche a causa delle loro dimensioni. Via Mario Angeloni non è Corso Vannucci, tanto per rimanere a Perugia. Immaginare il lato sinistro (in sinistra veicolare), di Via Mario Angeloni come un lato pieno di negozi, vetrine e dehors quello sì sarebbe un errore. Percorrere Via Mario Angeloni in sinistra per andare dove, poi? Non solo nel 1970, ma anche oggi? Per salire fino ai semafori di Via XX Settembre? Via Mario Angeloni era ed è una via poco “amichevole”, poco adatta ad avere attraversamenti pedonali a raso: il lato destro e il lato sinistro parlano due lingue differenti, e sarà così per molto tempo ancora. Attraversare Via Mario Angeloni è pericoloso. Aldo Rossi mette le attività sociali non all’interno dell’isolato, ma verso la piazza: fa l’unica operazione culturale e intellettuale possibile e sensata: trovare all’interno del proprio ambito di progetto un elemento rigenerativo per lo sviluppo futuro della città. A partire da lì: non per finire lì. Gli spazi i luoghi le attività di maggiore interesse si rivolgono verso la piazza e girano le spalle a quella che era ed è una trincea urbana. E inoltre, poiché il dibattito aumenta di interesse con il confronto, bisognerebbe immaginare che cosa avrebbero prodotto il progetto di Mario Botta o di Kenzo Tange (pure partecipanti al concorso), per capire che all’epoca il l’amministrazione comunale di Perugia fece la scelta giusta. Il lotto a disposizione è in quella situazione già difficilissima nel 1970, per dimensioni, quote e viabilità, non a causa di Rossi: malgrado Rossi.
Il secondo madornale errore sembra essere quello del broletto: “Dall’altro lato, a ovest, il Broletto è costruito sopra la via Cortonese, creando uno spazio che è tra i peggiori che si possano pensare in una città: un tunnel veicolare, buio e sporco, che ha l’unico scopo di smaltire un traffico veicolare intenso, creando una barriera per i pedoni”. Non capisco come avremmo potuto collegare la viabilità a monte della ferrovia con quella a sud se non facendo defluire il traffico in questo modo. Continuando a passare per Case Bruciate? Arrestare l’edificio regionale prima di Via Cortonese avrebbe tombato qualsiasi idea di piazza e tutto l’isolato sarebbe diventato un’enorme rotatoria. L’altra possibilità quella di scavare un vero e proprio tunnel con ingresso su Via Capitini e uscita a valle della ferrovia, con difficoltà inimmaginabili di ricollegare il traffico locale. L’edificio-ponte mi sembra una soluzione intelligente per risolvere problemi di spazio e di traffico allo stesso tempo. L’edificio a ponte consente di dare più “aria” alla Piazza che si va componendo, scavalcando i limiti imposti dalla viabilità. Mi pare questo uno degli elementi più interessanti del progetto di Rossi: fare spazio. Uscire dai limiti imposti dalla viabilità di scorrimento.
Sulle piazze: confrontare piazza del Campidoglio a Roma con Piazza del Bacio a Fontivegge è abbastanza facile. E imputare a Fontivegge di avere poche persone che animino la piazza anche. Ma sicuramente l’esempio è stimolante ed è bene tenerlo a mente. Ci torno tra poco. Sul rapporto tra le “piazze”: veramente vogliamo parlare di Vittorio Veneto in termini di piazza? Viene in mente a qualcuno una piazza frontistante una stazione ferroviaria che sia una vera piazza e non solamente un hub di scambio intermodale tra treno, autobus, taxi, tram? No. Perché la piazza della stazione è il luogo del transito per eccellenza, il luogo dei flussi, e non della socialità. Nessuno va in piazza della stazione per restare lì: dalla piazza della stazione si vuole generalmente andare via il prima possibile. Quando si esce dalla stazione e ci si ferma sotto il suo pronao laico si può guardare a destra o a sinistra. A destra abbiamo l’edilizia un tanto al kg, o meglio un tanto al metro cubo. A sinistra abbiamo un brano, incompleto ma significativo, d’architettura. Questa è, ridotta ai minimi termini, la differenza. Poi possiamo imputare a Rossi tutti gli errori del mondo, a patto di vedere anche gli errori degli altri, anche molto vicini. Ancora: esco dalla stazione e vedo una grande scalinata e un angolo urbano che mi dice che lì, subito dopo il cilindro, c’è una parte di città, anticipata appunto dalla scalinata e dal cilindro, da un angolo risolto compositivamente con le proporzioni della città. La grande scala (il Campidoglio torna, fatte tutte le debite proporzioni), è uno degli elementi della composizione urbana, come è sempre stato nella storia della migliore architettura. Veramente possiamo rimproverare a Aldo Rossi le barriere architettoniche per uno spazio urbano nel 1983?
In chiusura: personalmente non sono contro la demolizione, purché alla demolizione segua un progetto migliore, un destino migliore di quello che c’è. Non condivido il valore tutto positivo che l’amico e il professore Paolo Belardi vede nel fatto che la Soprintendenza abbia in animo di vincolare il complesso, poiché questi vincoli si trasformano spesso in Italia a obbligazioni rigidissime e al mantenimento dello status quo. Eviteremmo sì la demolizione, ma anche il completamento. Io invece mi auspico che la piazza venga completata, magari con un buon bando di concorso. Tuttavia chi conosce la materia sa che indire un concorso non ha senso se la proprietà privata non ha questa volontà. La soluzione di un’area così complessa può passare solo da un accordo pubblico privato, formale e sostanziale. Trovato l’accordo sarà facile poi individuare il percorso amministrativo più adeguato.
Solo grazie
#seed360 e #spaziosacro è stata un’esperienza fantastica! Per me sono stati 7 giorni di grande formazione e educazione: formazione è infatti riduttivo. Quindi posso solo ringraziare. Certo, ci sono state delle sbavature da parte mia e me ne prendo ovviamente la responsabilità. Qualche intervento è stato sotto alle aspettative (mie), e altri sopra. Ho scoperto amicizie e messo in luce sensibilità o fragilità altrui, e di questo mi dispiace. Credo tuttavia che luci e ombre, rose e spine, facciano parte di un’iniziativa così complessa e articolata. Ritengo di aver fatto il meglio che potessi fare, e mi pare un bel risultato per poter continuare a pensare a qualcosa di buono, in futuro. Abbiamo già ringraziato ufficialmente i nostri partner (privati e pubblici), e compagni di viaggio, e sono stati ringraziamenti veri, che però non posso ripetere adesso. Allo stesso tempo voglio evocare alcune persone con cui è nata una certa complicità o che comunque mi hanno colpito per lo spirito di abnegazione e per la generosità dimostrata in maniera del tutto spontanea e immediata. Dunque grazie a #nicolapalumbo con cui abbiamo condiviso avventure ambientali estreme “al limite della sopravvivenza” per “catturare” le riprese di Mario Botta a Mendrisio e di Paolo Portroghesi a Calcata. Grazie a #barbaracadeddu per aver tenuto sempre il timone a dritta anche quando il resto della ciurma si distraeva, a #barbaraargiolas per la sua calma sorniona, a #graziellatrudu per la discrezione e delicatezza, a #francescogubbiotti che ci osserva da dietro i suoi grandi e strani occhiali e ormai penso ci guardi come fossimo anche noi dei video da caricare sulla piattaforma. Grazie infine in ordine di tempo al sindaco di Bevagna #annaritafalsacappa che ci ha ospitato sabato sera e che ha incantato i nostri relatori con una serata piacevolissima fatta di gnocchi al sagrantino e iscrizioni medievali. Grazie A.M. (ma questa era prevedibile).
Franco Purini a Assisi il 30 aprile!
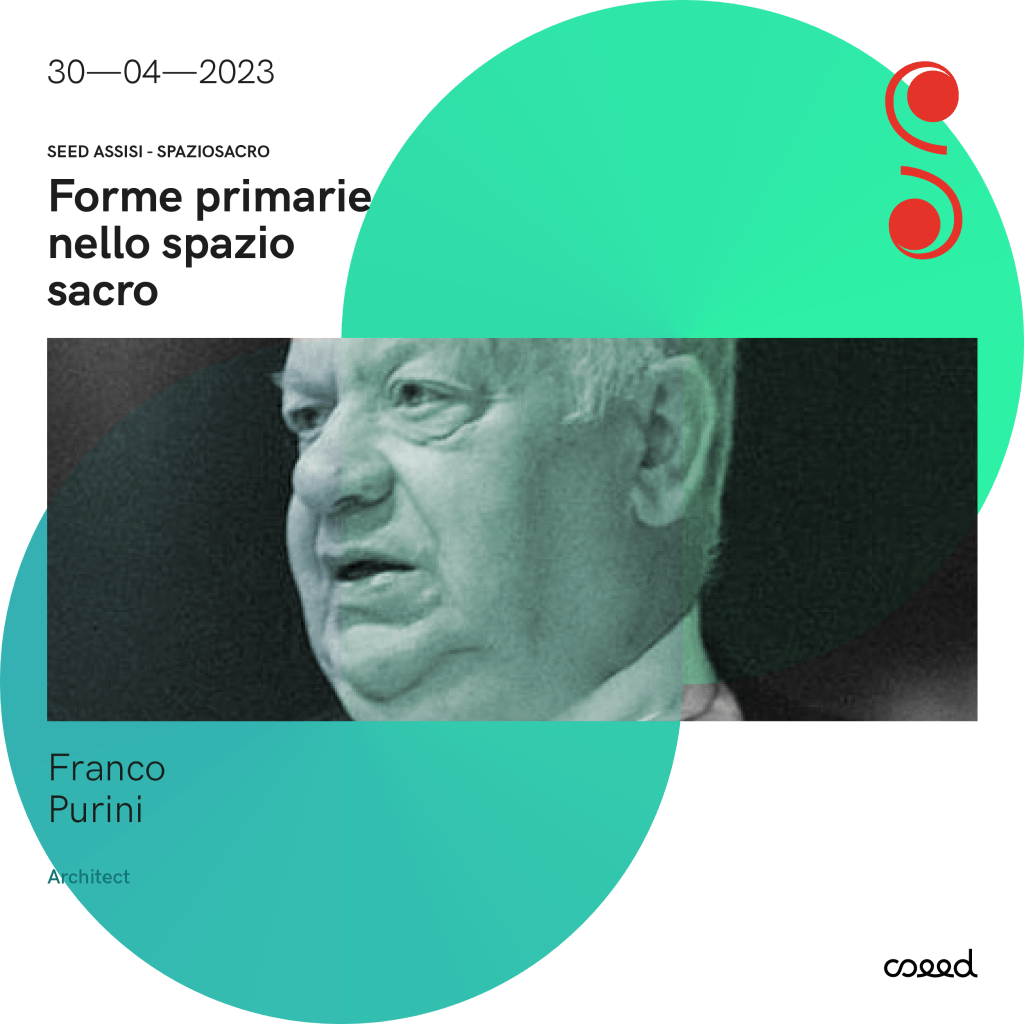
Seed
Le parole del corso*
Dico subito che sarà una lezione un po’ atipica, un po’ coraggiosa, senza immagini. Quasi uno scandalo! Trattare l’architettura, la composizione architettonica, senza immagini! Tuttavia con il professor Belardi abbiamo condiviso un’idea: che oggi di tutto avete bisogno meno che di immagini.
Sarà dunque una lezione densissima, particolare, profonda, durissima: chi vuole uscire deve farlo ora o mai più. 😊
Bene, allora iniziamo.
La lezione prende il titolo da questo libro che ho scritto 5 anni fa. E’ un libro che fa un’operazione abbastanza semplice, che molti prima di me hanno fatto, e che consiste nel prendere le lettere dell’alfabeto e nell’abbinare a ogni lettera una parola, e raccontare qualcosa su questa parola. Parlo di architettura, ma faccio riferimenti alla musica, alla letteratura, alla poesia, alla pittura. Una sorta di piccolo ipertesto cartaceo. Ogni parola è insomma e dunque anche un pretesto: un pre-testo. C’è una bella presentazione di Paolo Belardi e una postfazione di Mario Pisani, che ringrazio ancora. Ho scelto solo 3 parole su cui rifletto nel libro e una ultima che non è nel libro ma che mi serve perché riguarda una iniziativa molto attuale in cui sono coinvolto.
Consentitemi tuttavia una sorta di prologo, che vuole essere anche uno dei messaggi più forti che vi voglio regalare oggi:
“Non esistono sinonimi”. E’ una frase di Milan Kundera.
Può apparire strano che io inizi una comunicazione sull’architettura, sul disegno, sulla composizione, prendendo una piccola frase di Kundera che riguarda la lingua scritta o parlata. Non è una citazione famosa di Kundera: se googlate non la trovate. E’ una frase lapidaria che ho estrapolato da uno dei suoi romanzi. Per completezza e visto che siete molto giovani: Milan Kundera è uno scrittore cecoslovacco che negli anni tra i ‘70 e il 2000 ha scritto romanzi tra cui il più famoso L’insostenibile leggerezza dell’essere. Vi è poi un saggio che si chiama L’arte del romanzo, che insegna molta più architettura di tanti libri teoricamente più specifici.
A uno sguardo più attento, a un ascolto più attento, non sfuggirà che questa frase si può usare anche nel linguaggio più visivo del disegno, dell’architettura.
“Non esistono sinonimi” si tradurrà per noi in effetti molto speciali: in differenze. C’è una differenza tra guardare e vedere. E dovete imparare a usarli entrambi. Tra ornamento e decorazione, tra disegno e schema, tra esattezza e precisione, tra il sacro e il santo.
La prima parola è Disegno.
Ci sono scarabocchi, schizzi, studi, disegni, schemi, diagrammi. E poi prospettive, assonometrie, isometrie, rendering….. Queste forme di disegno hanno un autore (o anche più, a volte), e un pubblico (o anche più, a volte).
Faccio un cenno veloce allo scarabocchio. Lo scarabocchio è un disegno quasi automatico che alcuni di noi fanno in sovrappensiero. Non sarebbe quindi una forma di disegno cosciente. E’ una sorta di piacere che si trova nel fare ghirigori, quasi un riscaldamento della mano, una sua messa in moto, una lallazione della visione e della mano. Questo tipo di disegno non è destinato a nessun pubblico. Lo scarabocchio, lo schizzo, lo studio, il bozzetto, hanno un ruolo importantissimo perché consentono di mantenere in funzione lo strettissimo rapporto tra mano cervello e occhio. Abbiamo scoperto ormai da un po’ di anni che questo rapporto non è solo un rapporto “romantico”, ma è frutto di una coevoluzione. Il cervello si è evoluto e ha cominciato a specializzare alcune cellule, alcune delle quali sono diventate occhio. Il disegno, il disegno a mano, consente di continuare a usare questa formidabile sinergia tra il vedere il fare e il conoscere.
Devo subito distinguere tra vedere e guardare, che non sono sinonimi, anche se spesso i due termini vengono fatti oscillare. Per distinguerli facciamo così: guardare viene dal germanico e rimanda all’essere una guardia. Per me è un atteggiamento: sono guardingo. Sono attento un po’ a tutto. Devo essere recettivo al massimo grado.
Vedere viene invece dal sanscrito vèd: distinguo, so. Il vedere viene dopo il guardare. Il vedere è un atto intenzionale. Il vedere è già pensare. Ad ogni modo di pensare corrisponde un modo di vedere. Vedere è proattivo, selettivo, cognitivo.
Fatta questa necessaria distinzione, passiamo subito allo schizzo. Perché lo schizzo è importante? Innanzi tutto leggetevi il libro Brouillons d’architects del prof. Belardi.
Prima risposta: lo schizzo è importante perché è ancora vago, è fertile, è poetico, è aperto. Lo schizzo è una fase della composizione architettonica, del pensiero architettonico. Che sia reso più o meno sotto forma di immagine, di tratto, poco importa. Lo schizzo è l’output della prefigurazione. Leoncilli parla della precognizione, rimandando a Zuccari e a Vico.
E’ una fase dell’invenzione architettonica. E’ proprio una fase, non può essere eliminata. Può essere modulata, compressa o dilatata, ma non eliminata. Vi sono architetti che tra schizzo e realizzazione mettono pochissima distanza. Altri invece disegnano molto. Lo schizzo ha teoricamente un solo pubblico: se stessi. Teoricamente perché molti architetti fanno gli schizzi dopo i disegni professionali per esporli in mostre o per pubblicarli, per far vedere che sono bravi. Sullo schizzo posso tornare e modificarlo. Posso addirittura buttarlo via. Lo schizzo non ha grandi pretese, a meno che noi non gliele mettiamo in carico. Ognuno di voi deve trovare il proprio strumento di pensiero. Non c’è una via unica.
Il disegno poetico, il disegno poietico, il disegno generativo è fatto con la matita in mano e non con il computer, o meglio: non con autocad, sketchup, archicad, ecc. Potete disegnare al computer su un tablet su una tavoletta come vi pare, ma i primi disegni devono essere aperti, sintetici, veloci, senza pretese, disponibili ad accogliere le novità. Non potete saltare questa fase di avvicinamento all’invenzione architettonica. Non potete passare subito al disegno digitalmente esatto del CAD. In questa fase, a me non interessa la precisione esatta di autocad nel fare un offset di 47: a me interessano due rette parallele per rappresentare un muro consistente di circa 50 cm. Questa esattezza immediata disorienta. Perché tra l’altro, a questa esattezza binaria non corrisponde il dato tecnologico costruttivo vero. I vostri segni sono esatti, ma non sono precisi, non sono adeguati, coerenti con lo scopo. Voi fate un offset di 47, ma non sapete ancora (perché non l’avete deciso, nel migliore dei casi, o perché non sapete proprio come si fa, nel caso peggiore), di cosa sarà fatto questo muro. Siamo di fronte a un paradosso logico: abbiamo una esattezza pressocché infinita, ma completamente cieca, completamente muta. E’ una delle ragioni per cui preferiamo gli orologi analogici e non quelli ultra precisi: sono le cinque e un quarto, non le 17 e 16 e 34 secondi.
La seconda è perché: “Il disegno realizza un perfetto sincretismo tra il vedere, il fare e il sapere: imparare a disegnare, acquisire il saper-fare un segno, implica l’acquisizione di un’altra capacità, quella di saper-vedere ciò che di una data cosa s’intende disegnare.” (Giuseppe Di Napoli)
Cerco di dirlo ancora meglio: “Il disegno non è la forma, è il modo di vedere la forma.” Paul Valéry
“Solo imparando a vedere si può disegnare bene, di converso è altrettanto vero che solo disegnando si impara a vedere meglio.” (Giuseppe Di Napoli)
Questa ulteriore citazione chiarisce meglio una frase di Carlo Scarpa che mi era sempre sembrata fuori luogo, detta da lui: “Io disegno per vedere”. Perché dice così? Perché nel disegnare uno può anche verificare la bontà della sua prefigurazione, ma credo che il senso più profondo vada ricercato nel fatto che mentre disegno un oggetto capisco quali sono le domande che devo fare a quell’oggetto, quali sono i suoi punti deboli, dove ho bisogno ancora di pensare meglio.
Perché allora non sappiamo disegnare? Perché non sappiamo vedere!
“Io so benissimo che alcune cose non le so ancora vedere …” Goethe
Per vedere bisogna tornare innocenti, vergini, ignoranti. Bisogna togliere tutti i blocchi di conoscenza già pronta all’uso che abbiamo rispetto a quell’oggetto. Per disegnare bisogna dimenticare, bisogna interrogare. Noi invece non interroghiamo: disegniamo già quello che abbiamo in testa. E con ciò replichiamo solo quello che già sappiamo. Il disegno è una domanda: allora è un buon disegno.
Ancora una distinzione: il disegno non è il talento. Non è il bel disegno. Devo mettervi in guardia dal talento: il disegno di cui parlo non è il bel disegno. Ci sono dei bellissimi disegni che si rivelano delle realizzazioni mediocri, e ci sono invece dei disegni aridi che sono delle realizzazioni fantastiche (Adolf Loos, Mies). Vi leggo un brano di un intervista fatta a Mies van der Rohe.
<>
Ovviamente non vi sto spingendo a sedervi tutta la mattina e fumare tre sigari, ma a pensare sì!
La seconda è Ornamento.
L’ornamento non è la decorazione.
Si decora un militare dopo un’operazione tattica. Si decora una casa per il rientro a casa del soldato alla fine della guerra. Si decora la casa per le feste di Natale. La decorazione è operazione successiva.
L’ornamento è contemporaneo, sincrono, incarnato nella costruzione.
La decorazione si applica. L’ornamento applica. Prendete per esempio Casa del Fascio di Terragni a Como: nessuna decorazione, tutto ornamento. Tutto ordinamento. La disposizione (la dispositio, la chiama Vitruvio), degli elementi nello spazio è or(di)namento: è il primo ornamento. Ornare può farsi risalire alla sincope di ordinare. Il tempio dorico ha un suo ornamento e una sua decorazione. L’ornamento del tempio dorico è la sua metrica, la sua alternanza matematica di triglifo e metopa. E’ la proporzione delle parti in sé e il ritmo tra le diverse parti. La decorazione è nei colori che potevamo avere per il fregio, per la metopa, per il triglifo. E’ così vero che oggi i templi che vediamo hanno perso la loro decorazione ma non il loro ornamento. L’ornamento è il “portamento”.
Con il Movimento Moderno noi abbiamo buttato via ornamento e decorazione, e cioè il bambino con l’acqua sporca.
Oggi qual è la strada? Perché dobbiamo, dovete, dovrete trovare un punto d’equilibrio tra l’astrazione di un grado zero dell’architettura, dove non c’è ornamento, non c’è decorazione (e forse non c’è più niente) e un’architettura dove oggi tutto si traduce in decorazione. Ci può essere una decorazione “ben temperata”, insomma.
E’ evidente che molta dell’architettura di oggi si traduce in decorazione e che dunque è destinata a resistere molto meno del colore dei fregi del Partenone. Molta dell’architettura hi-tech è per me sola decorazione. Tecnologica, ma decorazione. Ieri sui social ho visto un gruppo di ragazzi di edilizia acrobatica che sono andati a pulire i vetri del centro della Protezione civile a Foligno. Quello è per me il regno della decorazione.
E’ evidente che c’è anche molta architettura che si declina in tutto ornamento: penso per esempio (un piccolo scandalo, per chi mi conosce), alle cose di Zaha Hadid o anche all’ultimo Mario Cucinella nella chiesa di Mormanno, in Calabria. Sono edifici bianchi o comunque spogli. Non hanno decorazione. E’ la loro geometria che è straniante, perché non siamo più in grado di descrivere la grammatica generativa che le produce. Se siamo ancora a nostro agio con le forme che si possono descrivere (triangolo, cerchio, quadrato, diagonale del quadrato, sezione aurea, ecc.), quando andiamo sui paraboloidi iperbolici siamo in difficoltà. Immaginate con le forme di Gehry, Hadid, o con i risultati dell’architettura parametrica. Quell’algoritmo generativo è diventato complicatissimo e non siamo più in grado di gestirlo, di descriverlo, di narrarlo, quindi oggi è passato alle macchine. Il computer riesce a gestire questo algoritmo, che produce delle nuove architetture. Non solo nuove nel senso che vedono la luce adesso: sono nuove perché a mio avviso abbiamo bisogno di una nuova estetica per valutarlo. Abbiamo bisogno di nuovi criteri, di nuovi parametri.
Impossibile rilevare con il metro e la sezione aurea il centro di Bilbao o le architetture di Unstudio, di Ishigami: occorre un laser che ri-produce l’oggetto. Non lo rappresenta più: lo deve ri-produrre. Per costruire il tempio dorico voi avete bisogno di due sole misure: il diametro della colonna all’imoscapo e lo spazio vuoto tra una colonna e l’altra: tutto il resto è funzione di questo modulo: altezza della colonna, architrave, metopa, triglifo, ecc. Impossibile ricostruire Bilbao con due dati in ingresso.
Le nuove architetture organiche ci fanno tornare nelle caverne. Se ci fate caso, la spazialità che ne esce è quella delle caverne, di un spazio fluido, di una spazialità magmatica. Non c’è nessuna decorazione (spesso sono solo strutture, travi, involucri o spazi negativi). E’ tutto ornamento. Dobbiamo decidere se questa architettura ci piace o meno. Non è solo questione di gusto: le cose che hanno valore per noi sono le cose per cui siamo disposti a pagare un prezzo. Impossibile giudicare la Cappella Pazzi con gli stessi occhi del MAXXI di Roma: è cambiato il gioco. Le cose belle hanno bisogno di sacrificio.
Ornamento o decorazione che sia, nel mondo moderno circola una droga. La novità è una droga che ha cominciato a circolare in maniera intollerabile dai primi del 900. La novità non è un valore in sé. Ci sono delle cose antiche, vecchie, che sono delle cose straordinarie. E ci sono delle novità che sono delle castronerie pazzesche. Ecco una novità: mammma. Il suono è pressapoco lo stesso, ma è un errore. Ora, in architettura non esiste una corrispondenza così netta tra un significante e un significato, ma ci sono degli esempi in cui le novità sono talmente innovative che sono degli errori.
Vi sono per esempio delle case olandesi cubiche, solo che sono appoggiate al suolo sullo spigolo. Vi è un limite alla sperimentazione in architettura. E quindi la novità deve essere una novità ben temperata. Non può essere una radicalità. All’Università potete forse esagerare, ma poi la professione dell’architetto non può essere solo votata alla ricerca. Anche qui dovrete trovare un vostro equilibrio.
Cerco di inocularvi un po’ di vaccini contro la novità.
Il primo è di Claudio Parmiggiani: “C’è una domanda che mi si pone spesso: perché nei miei gessi vediamo sempre tornare la stessa figura? Io non penso a soggetti differenti, non penso a dei ritratti, ma a una immagine. Una immagine per sempre. E’ quello che succede nelle nature morte di Morandi; interrogare un viso durante tutta una vita, e fare in modo che durante tutta la vita questo viso ci interroghi”.
Il secondo vaccino è forse più pertinente: il progetto di Lacaton e Vassal a Bordeaux Place Aucoc
Stravinskij disprezza ogni brama di libertà: «L’insubordinazione si vanta del contrario ed elimina la costrizione con la speranza, sempre delusa, di trovare nella libertà il principio della forza; vi trova solo l’arbitrio dei capricci e i disordini della fantasia, perde così ogni specie di controllo, si disorienta». Dal suo punto di vista, un artista che cerca deliberatamente la novità rimane intrappolato proprio nella sua stessa aspirazione: «La sua arte diventa veramente unica, nel senso che non può essere comunicata e che è chiusa in sé stessa».
Veramente questa sua opera non può essere comparata con altre. L’artista si pone in qualche maniera come una monade. Rifiuta di giocare a calcio, rifiuta di giocare a basket, rifiuta di giocare a scacchi e ogni volta si inventa un proprio gioco di cui noi non conosciamo le regole e spesso non le conosce nemmeno lui. A volte è così disturbato dal risultato che deve inventarsi delle regole ex post. La libertà assoluta vi può trasformare in genio, inimitabile per definizione. O in una schiappa totale, da non imitare.
Con cosa possiamo sostituire la novità, nell’invenzione architettonica? Con la densità e la coerenza. La densità delle idee che riuscite a mettere sul tavolo e la coerenza tra un’idea forte e il suo sviluppo, la sua metrica, la sua immagine. In questo modo aspirate a divenire classici. Il classico è ciò che non esaurisce mai le risposte, come dice George Steiner.
La terza parola è luce.
La luce, a cui ci rivolgiamo sempre o quasi sempre al singolare, è in realtà plurale.
Si può subito distinguere, per esempio, tra la luce naturale e la luce artificiale. E si può dividere ancora la luce naturale in luce solare e luce lunare.
La luce solare varia nel corso della giornata e nel corso dell’anno. Ovviamente varia in funzione del luogo, e anche in funzione dell’altitudine: se siamo in cima all’Everest è diversa che se stiamo sul Mar Morto.
E’ evidente per esempio che la luce cambia di molto tra Santa Maria di Leuca e le valli svizzere. Nella prima, in estate, c’è un aspetto di ampiezza, di luminosità, o allora di pastosità, di tattilità, che nelle seconde non si ritrova. E anche la velocità con cui questa luce cambia è diversa: in Svizzera può capitare di essere anche fisicamente sorpresi dalla repentinità del cambio: si può andare dall’azzurro terso al grigio cupo in pochi minuti.
Il variare della luce dà luogo a un fatto curioso: che lo stesso monumento suscita emozioni diverse, in funzione dell’ora, in funzione del giorno. Non completamente diverse, è ovvio. L’edificio si “colora” appunto di sfumature diverse: se ne apprezza qualcosa di diverso, si legge meglio una modanatura, appare più accogliente, o più freddo. Pensiamo alla Cattedrale di Rouen dipinta da Monet sempre dallo stesso punto di vista, in condizioni differenti. Allo stesso tempo, se invece lo stesso edificio potesse essere trasportato in luogo affatto diverso, ne deriverebbe un’emozione completamente diversa. Pensiamo l’effetto che potrebbe avere il Pantheon al Polo Nord. L’architettura è abbastanza sensibile al luogo (eufemismo), e questo la distingue un po’ dal design.
Nonostante questa grande variabilità, a me pare (da una personale introspezione e da ricerche personali presso amici), che generalmente l’architetto pensi e progetti in una sola luce. Non so se questa affermazione sia sempre e per tutti vera. Finora, tuttavia, non ho sentito, anche nei vari racconti autobiografici, una simile attenzione verso la luce nella progettazione o prefigurazione. Forse è solo un fatto di mancata verbalizzazione o forse è proprio una fase a cui non si presta attenzione. Sembra che ci sia un’immagine dominante, una luce dominante (una nota dominante?), che subordina a sé tutte le altre. In prima approssimazione direi che ci sono due tipi di architetto: il primo pensa la sua architettura immersa nella luce serena e imperturbabile di un Piero della Francesca (Brunelleschi, Alberti). Il secondo pensa la sua architettura nel flusso del tempo e della luce (Palladio, Le Corbusier, Campo Baeza). Devo dire che molto spesso, sia in un tipo che nell’altro, è un’ombra fissa, cristallizzata in un solo momento. Noi invece dovremmo imparare a progettare delle belle ombre, in vari momenti del giorno.
La luce solare nasce e muore sulla linea dell’orizzonte. E’ forse una banalità, ma anche questa la distingue dalla luce artificiale. La luce solare per esempio, non potrà mai essere da sotto in su, rispetto a un edificio, come invece può fare (e fa, nella grande maggioranza dei casi di illuminazione, soprattutto notturna), la luce artificiale. Di notte, se la luce è diretta verso il basso, possiamo verificare che l’architettura termina con la sorgente di luce, poiché la parte superiore non verrà quasi percepita. A volte vedo architetture illuminate dal basso in alto, con una luce radente (cosa quindi del tutto innaturale), senza avere alcuna intenzione di evidenziare la materialità del muro. Lo si fa spesso perché è diventato un modo di fare, e il risultato scenico è garantito con poco. E’ insomma un espediente facile, che dà facilmente risultati scenografici. Altre volte, invece, soprattutto nel caso di castelli medievali vengono messe fonti di luce per ogni arcatella del muro di cinta. Con il che risulta illuminato il muro sottostante ma quasi sparisce la merlatura soprastante, che forse ha anche maggiore dignità e pregio. Tra l’altro, spesso, questi castelli sono illuminati con luci che non hanno mai avuto, né nella mente dell’architetto, né nella loro vita trascorsa. In generale tutti i nostri monumenti edifici, architetture, sono stati illuminati da poche torce, candele, caminetti, e mai da grandi luci diffuse. Forse solo in occasione di particolari feste venivano illuminate da una moltitudine di piccole luci puntuali, ma mai da una così potente luce diffusa. Sicché abbiamo spesso dei castelli da favola, letteralmente. Ormai questi edifici costituiscono un nuovo tipo di paesaggio notturno.
La luce naturale del sole fornisce una coordinata spaziale e cronologica al nostro mondo. O meglio: consente di ricostruire uno spazio “temporale”, un quadro, uno scenario, una finestra, uno sfondo entro il quale il tempo può darsi, può apparire, può muoversi. La luce artificiale, nella propria fissità, ci ritorna paradossalmente una luce ultraterrena, mitica, illusoria. Una sola luce, fissa, ora e per sempre. E’ vero che oggi le luci possono essere controllate e modificarsi nel tempo. Tuttavia non conosco esempi significativi e interessanti di luce modulata durante la notte, a parte performance artistiche temporanee. E non saprei dire se questa mutevolezza sarebbe così gradevole.
La luce lunare è molto espressiva e tuttavia è stata poco frequentata dagli architetti. L’architettura si trova insomma immersa quasi per caso nella luce lunare e non perché, invece, vi è stata pensata. Forse invece dovremmo progettare in funzione della luce artificiale, così come facciamo per la luce naturale, visto che la nostra vita si svolge la notte come il giorno. O in funzione della luce lunare.
Un’altra differenza importante tra la luce artificiale e naturale qual è? La luce solare mette sullo stesso piano l’architettura oggetto della nostra attenzione e le altre altre architetture (lo sfondo), la luce artificiale consente di esaltare i pesi e le evidenze, di modulare.
Vediamo velocemente come la luce possa giocare con la materia.
La luce radente è quella luce che scende, come fosse un velo d’acqua, su una parete. La luce radente esalta la materialità della parete o dell’oggetto. Lo fa a causa delle ombre lunghissime che il materiale proietta su se stesso. Se il materiale è liscio come il vetro, ad esempio, la luce produce pochi effetti e completamente diversi da una parete di mattoni. Tutte le imperfezioni del materiale ci ritornano e ci forniscono quasi una impressione tattile del materiale stesso. Dunque la luce radente funziona meglio se c’è un materiale da valorizzare. Io credo che ogni materiale abbia una sua luce preferita. Ovviamente la luce radente riflette poco verso il resto dello spazio e quindi non è molto adatta a illuminare funzionalmente gli ambienti. La luce radente, se è naturale, può essere solo temporanea. C’è una “finestra” temporale in cui possiamo averla: la luce naturale non può essere radente per sempre. La luce radente del mattino o della sera mette in risalto gli aggetti verticali: la luce del mezzogiorno mette in rilievo i profili orizzontali. Se siete bravissimi potete pensare anche a questo nel comporre.
Ci sono poi dei “rallentatori” di tempo che i grandi architetti hanno sempre usato: inclinare il muro nel suo profilo verticale (un muro a scarpa ha più “tempo”), o curvare il muro nel suo andamento in pianta. Le pareti “a scarpa” danno ovviamente come effetto secondario una luce riflessa. La luce di rimbalzo può essere in alcuni casi intensa: dipende dall’ora, dal materiale, dall’inclinazione del muro. La luce radente del mattino o della sera è in realtà una luce diretta sulle pareti verticali. In questi casi cambia solo la qualità della luce, che ha una componente rossa più elevata. Anche se proveniente da uno stesso tipo di orizzonte (cosa che si dà rarissimamente qui in Europa, a meno di essere in mezzo al mare), la luce del mattino è più pulita mentre la luce della sera è più “polverosa”. Ma questo succede solo perché l’umidità notturna ha “lavato” l’aria.
La luce zenitale solare è una luce che ha poche ombre, qui da noi. O meglio: che noi idealizziamo figuriamo, senza ombre. È la luce del mediterraneo. La luce zenitale è ovviamente un’idea, un mito. Che è tale solo quando il sole è al mezzogiorno, il che avviene, ovviamente, solo in un momento, a essere precisi. La differenza del mezzogiorno di Palermo con quello di Stoccolma è evidente e credo che chiunque abbia viaggiato anche poco abbia notato questa differenza. Cambia l’intensità della luce, il suo colore, la sua durata.
La luce può essere diffusa, orientata o concentrata. La luce diffusa si può ottenere con facilità dalla luce solare facendola “faticare”, mettendo degli ostacoli sul suo cammino: acqua, vetri acidati, pellicole, lastre di pietra, gesso, teli, tessuti, labirinti, ecc. Oppure la si può far rimbalzare sul pavimento, mettendo una finestra bassa come fa Carlo Scarpa a Castelvecchio, oppure su un bacino d’acqua. La luce diffusa cambia ovviamente con il passare del tempo. Oppure, se la volete sempre dello stesso colore e della stessa intensità dovete rivolgervi a nord, come facevano molti grandi pittori e scultori.
La luce naturale concentrata (l’opposto esatto della luce diffusa), è più difficile da ottenere e raramente, anzi mai, che io ricordi, l’ho vista in azione in architettura. Solo Archimede mi sembra l’abbia usata e a fini militari. D’altra parte, anche in questo caso il meccanismo funziona solo per un periodo di tempo ben preciso, o allora è necessario “inseguire” il sole.
Dobbiamo distinguere meglio tra luce concentrata e luce orientata. La luce concentrata è la luce che risulta da una concentrazione, da una “densificazione” (mi si passi il termine), della luce solare e che dunque ha bisogno di una qualche tecnologia per realizzarsi (specchi). La luce orientata è realizzata invece ponendo in ombra alcune parti e indirizzando molta luce su altre parti, in maniera tale da avere un notevole contrasto. Con il sole riusciamo a ottenere quest’effetto con dei canons à lumière, (il convento di La Tourette di Corbu e Xenakis, ma anche le ferite di Fuksas a Foligno), che funzionano molto bene soprattutto se sono orientati verso il sole. Va da sé che con il passare del tempo, l’intensità di questa luce e la sua composizione cromatica cambiano. Ovviamente con la luce artificiale oggi si possono ottenere degli effetti più intensi e più durevoli.
La luce “spot”, quindi circolare, è di solito molto intensa e serve a evidenziare un particolare specifico.
Ecco: forse un’altra distinzione può farsi tra le luci che servono a illuminare un pieno e le luci che servono a illuminare un vuoto. La luce dell’oculo del Pantheon è un fascio di luce circolare che serve a illuminare un vuoto, che serve a misurare. Lo gnomone inverso che è il Pantheon serve a misurare il tempo e serve a misurare lo spazio, perché ne dà piena contezza. La luce del Pantheon permette di misurare lo spazio non solo perché illumina lo spazio stesso e quindi consente una valutazione sintetica delle dimensioni, ma perché potendo misurare la sua impronta a terra (la sua ellisse), permette di proporzionare il resto. Questa possibilità di misurare lo spazio esiste solo se c’è la possibilità di commisurare e quindi avere un oggetto di paragone, che può essere un oggetto fisico di cui conosciamo già le metriche. In questo caso un raggio di sole che disegna un’ellisse dà luogo appunto a un oggetto conoscibile e misurabile su un piano, in immediato paragone con la nostra fisicità, con la nostra dimensione. Si veda infatti la nostra incapacità di misurare lo spazio nelle grotte di Frasassi, per esempio, pur se illuminate. Non siamo in grado di misurare perché non siamo in grado di commisurare. Misurare è sempre commisurare.
La luce di Santa Sofia, nella teoria delle piccole finestre tra tamburo e cupola principale ha lo scopo principale di smaterializzare la Cupola, di renderla autonoma e sospesa. In questo è proprio il contrario del Pantheon: non deve trarre in inganno il fatto che sono forme analoghe dal punto di vista geometrico. Il Pantheon è un luogo etrusco, dove si sente la massa che sta sopra di noi.
La luce usata “in controluce” rende più scuro l’oggetto in primo piano. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che gli spilli di luce ci costringono a ridurre il nostro diaframma e quindi a ridurre l’intensità che colpisce il nostro occhio. Il muro di Ronchamp, visto da dentro, in alcuni punti sembra un semplice velo. In altri punti invece, dove Le Corbusier ha scavato lo spessore del muro, lo ha strombato, lo ha graffiato, inciso, lavorato, asportato, si vede tutta la massa. Se infatti il buco è netto e passa solo la luce abbiamo un effetto di diaframma adimensionale. Se invece riusciamo a vedere la luce che corre, che scivola sulla parete, riusciamo a percepire la dimensione fisica, la gravità.
La luce consuma lo spazio? Se stiamo ai greci: sì. Questa cosa può avere la nostra conferma empirica soprattutto nel caso di un corpo posto in piena luce e che abbia come sfondo una enorme profondità. Ci hanno sempre detto che l’entasi della colonna serve a compensare l’effetto di consumazione della materia. In realtà l’entasi non è un rigonfiamento al cento della colonna: è una rastremazione che parte a un terzo del fusto e che diventa più fina secondo una curva e non secondo una linea. L’entasi è più un rapporto di empatia con la colonna con il suo sforzo che una compensazione ottica. La luce consuma gli estremi degli oggetti, i bordi e non la massa centrale. Tra l’altro, mentre il profilo liscio della colonna accentua ancora di più questo effetto di consumo, i profili netti delle striae delle colonne doriche o dei pilastri quadrati “resistono” meglio. La luce consuma anche a causa del pulviscolo. Il caso delle montagne in lontananza, che diventano sempre più chiare, è emblematico. In questo caso però e paradossalmente è la luce a essere consumata dalla materia (dalla polvere).
Credo che la funzione della luce in architettura sia duplice: creare lo spazio, come molti grandi architetti dicono (e fin qui si tratta di una cosa arci-nota). La seconda mi sembra meno nota ed è creare il tempo. È solo il tempo che riesce a dare una connotazione emotiva alla luce. Se la luce fosse sempre una sola, fissa, non sarebbe possibile darne connotazioni psicologiche e emotive. Se a volte la luce è dolce, accecante, languida, lattuginosa, sensuale, fredda, ecc. è proprio a causa della sua variabilità. O almeno è proprio in virtù della sua variabilità che abbiamo potuto apprezzarla in varie modulazioni. Ecco perché la luce naturale mantiene tutta la sua importanza per i grandi architetti e per le grandi architetture: perché permette di far sentire il tempo che passa. Permette di farci sentire a casa, sulla Terra. Anche se gli architetti pensano probabilmente a un solo effetto prevalente, che predomini e riassuma tutti gli altri, tuttavia non possono impedire che la luce, variando, produca altri effetti.
Abbiamo diviso il giorno e la notte in 24 parti uguali, ma sotto il profilo psicologico, come ognuno può intuire, l’ora del mezzogiorno dura più dell’ora al tramonto. Tra le 11 e le 15, d’estate, il tempo scorre lentamente, mentre avvicinandosi al tramonto il sole va più veloce. A me capita ancora adesso nei momenti di puro ozio, di verificare quanto velocemente l’ombra guadagni terreno, vicino al tramonto. La notte, da un punto di vista psicologico, non è che un unico intervallo poco significativo. Da questo punto di vista la meridiana è più “vera” è più “precisa” dell’orologio.
La quinta è il Sacro.
Perché ultimamente sono tornato a questo tema? Che è anche un ritorno alle origini: il rifiuto di progettare la mia tomba, tema di esercizio del quinto anno alle superiori.
Perché nel sacro avrete sì vincoli di bilancio, di tempi, di committenza, di burocrazia, ma avrete anche il dovere di fare una cosa che vi vada oltre. Nel sacro vi è una densità di significati da mettere in gioco che negli altri temi si trova difficilmente. Per fare un centro commerciale a volte bisogna essere così bravi da trovare il modo di addensarvi dei significati. Nel sacro forse dovete trovare la maniera di scartarne alcuni. Il sacro non è per forza santo. Santo è colui che è diverso dal profano, che aderisce alla divinità, che gli è prossimo. Vi possono essere luoghi sacri senza uomini santi. Mi sembra che solo in italiano si dica camposanto (che trovo bellissimo), indicando il cimitero.
Nel sacro il vostro committente non è più il vostro committente, anche se lui non lo sa. Lui è la maschera di un committente più grande, che viene da lontano, e che vi fa sentire la gravità del proprio sguardo. Il committente del sacro è la cultura tutta di un popolo di una collettività. Voi dovete rispondere prima a quello e poi al vostro committente occasionale, incidentale. Non è facile, e qui vi serve la vostra cultura, la grande cultura classica, la vostra sensibilità. Le grandi architetture nascono da un padre (il committente) e da una madre (l’architetto). A volte il vostro lavoro è più su voi stessi e sul vostro committente che non sull’architettura.
Paradossalmente lo spazio sacro è dove appunto si incontrano il tempo e lo spazio. O meglio: lo spazio sacro è quel dispositivo architettonico che consente al tempo di rallentare, di dilatarsi. Non a caso la composizione dello spazio sacro è legata sempre molto fortemente alla progettazione della luce. E la luce è interessante per un architetto se riesce a comprenderne le possibilità espressive legate allo scorrere del tempo. Direi quindi che la luce è proprio lo strumento “plastico”, paradossalmente, con cui il compositore riesce a portare a sintesi la triade spazio-luce-tempo. D’altra parte luce e luogo condividono la stessa radice etimologica.
Il sacro deve mettere in evidenza, in dubbio, in crisi, il rapporto dell’uomo con il tempo e con la memoria. Un tempo finito, umano, cronologico, che deve fare i conti con un tempo infinito, aionico. Ecco, cercare di far parlare questi due tempi è a mio avviso compito della luce. Pensiamo solamente, e a mo’ di esempio, alla differenza di “tempo” tra l’architetto egizio (le grandi sale ipostile, le piramidi), e l’architetto della cattedrale gotica.
Il sacro è sempre un’azione di costruzione. O al massimo di proiezione, di riconoscimento. Credo infatti che il riconoscere la sacralità di un luogo naturale sia comunque un’operazione di proiezione culturale. Poco significativo pensare a un’operazione quasi sciamanica, comunque elitaria, dominio di pochi “rabdomanti” capaci di percepire energie naturali tout-court. Certo, ci sono luoghi naturali che ci colpiscono subito e nei quali sentiamo che c’è qualcosa di diverso, di speciale, di forte. A partire da una radura nel bosco, luogo concettuale caro agli architetti e ai filosofi, a una sorgente in mezzo al deserto, a una cima particolarmente dura, aspra, a un lago fermo tra le montagne. Ma se a questo sentire, a questo riconoscere, se a questo arrendersi, non segue un ampliamento della nostra coscienza, della nostra sensibilità, direi che il sacro si è inaridito, che è diventato sterile e che ha fallito il suo più grande compito. Più difficile dunque, ma molto più interessante, più sociale, pensare a un’operazione di costruzione. Ri-costruzione del senso e costruzione del luogo vanno dunque insieme. Siamo noi che rendiamo sacro il luogo. Nel riconoscerlo sacro, lo rendiamo di nuovo sacro.
Lo spazio sacro, pur nei momenti più gravi, è sempre un punto dove la speranza continua a sopravvivere. Senza speranza non ci sarebbe la vita. Il sacro è dunque quel luogo dove c’è una compresenza e dove avviene una sintesi tra il senso della perdita, della nostalgia, e il senso della vita che continua e che si rinnova. Ancora una volta il tema del tempo ritorna come protagonista. Non è il luogo della felicità, del sorriso, del riso. Lo abbiamo visto prima: è il luogo della serietà. E’ il luogo della riflessione e della tranquillità, della saldezza, della forza.
Nei momenti più difficili l’uomo si rifugia sempre nel sacro: per pregare, per chiedere, per sperare, per continuare.
* Traccia della lezione tenuta presso il Dipartimento di Ingegneria a Perugia il 19 aprile 2023
Alcune riflessioni nulla nozione di Ristrutturazione edilizia, con riferimento anche alla legge regionale umbra
L’occasione di questa riflessione è stata quella di una docenza fatta a VillaUmbra il 16 febbraio 2023. Le note che seguono sono state un po’ il filo conduttore della docenza.
La definizione di ristrutturazione edilizia va analizzata attentamente poiché è oggi quella che pone maggiori problemi, sia per la formulazione della norma, sia per il peso che ha oggi nell’attività edilizia. Va esaminata distinguendola anche dalle distinzioni prossime: il risanamento conservativo dal basso e la ristrutturazione urbanistica dall’alto. È bene ricordare in premessa che la definizione degli interventi fu “codificata” dal legislatore per la L. 457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale). Poi tutti si sono adagiati alla tassonomia prodotta. Ma forse sarebbe necessario ripensare radicalmente le categorie, come vedremo meglio in seguito.
Alcune note metodologiche: a) numero i singoli periodi della nozione di ristrutturazione edilizia per facilità di lettura e di comparazione, senza modificare il contenuto della norma; b) le mie riflessioni e opinioni personali sono in nero contenute nelle parentesi quadre, mentre i riferimenti di legge sono in blu.
Dunque oggi, ex DPR 380/2001, abbiamo queste nozioni e definizioni.
Art. 3 co. 1, lett. c) 1. “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. 2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;”
Art. 3 co. 1 lett. d) “interventi di ristrutturazione edilizia”. 1. gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 3. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione [sic!] di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. 4. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. 5. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 6. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
Art. 3 co1 lett. f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
[La prima differenza che si nota tra il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia è di tipo logico-interpretativo. Il risanamento tende a conservare, la ristrutturazione edilizia a trasformare. Io ritengo che il legislatore nel 1978 pensi a degli interventi di risanamento come interventi di “pulizia” degli edifici storicizzati o di quelli storici dalle superfetazioni in primo luogo. E poi pensi banalmente a migliorare gli impianti tecnologici minimi per un abitare dignitoso: bagni, impianti di riscaldamento, caldaie, canne fumarie, ecc. Con una forte preferenza al mantenimento dell’uso attuale.]
Riscrivo la lettera d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, seguendo la numerazione appena attribuita.
- gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. [Innanzi tutto si parla di “organismi edilizi” e non di edificio, anche nel resto dell’articolato, il che porta a fare una differenza che tuttavia non è mai chiarita dal legislatore. Sembra insomma che ci sia una certa “leggerezza”, da parte del legislatore, ad adoperare indifferentemente edificio o organismo edilizio. Com’è facilmente intuibile, inoltre, la locuzione “trasformare in tutto o in parte” pone qualche difficoltà gestionale. Trasformare in parte un edificio avviene infatti già con la manutenzione straordinaria. Qualsiasi intervento modifica in parte l’edificio preesistente. Qualche Comune ha cercato di uscire in qualche modo dall’ambiguità tentando di fornire, attraverso il Regolamento Edilizio, una serie di criteri con i quali determinare se la trasformazione era parziale anziché totale: percentuale di mc o mq rimasti immutati, una quota minima di superficie, una quota minima di strutture, ecc. Si tratta di episodi per cercare di risolvere “dal basso” i problemi operativi che tecnici di parte e uffici comunali si trovano quotidianamente ad affrontare. Anche la locuzione “insieme sistematico”, apparentemente facile, pone difficoltà: se un intervento non è sistematico, o meglio na fa parte di un insieme sistematico, può essere considerato risanamento conservativo? Cos’è dunque il sistematico in edilizia?]
2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. [Il verbo “comprendono” all’indicativo presente parrebbe non lasciare scampo e forse darebbe ragione della sistematicità richiesta dal periodo precedente. Sarebbero insomma sistematici quegli interventi che comprendono (congiuntamente), il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e sarebbero sistematici gli interventi che prevedono l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.]
3. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. [Qui il discorso si fa subito molto più complicato. Innanzi tutto la prima “e” sembra del tutto congiuntiva, e quindi l’intervento deve comprendere allo stesso tempo e cioè, nella forma amministrativa, nello stesso procedimento, la demolizione e la ricostruzione (cosiddetta demo-ricostruzione). Mentre invece il resto della frase, con i diversi elementi elencati e divisi da virgole, deve intendersi come disgiuntiva, alternativa. Non è necessario insomma che allo stesso tempo ci sia diversità di sagoma, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, ecc. per avere ristrutturazione edilizia. Basterebbe una diversa sagoma, per esempio. Tuttavia siamo al limite, poiché anche il risanamento conservativo può portare a una diversa sagoma. Vediamo infatti la definizione di sagoma nell’elenco delle 42 definizioni comuni: “Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.”. E’ sufficiente infatti l’ultima parte della disposizione sul risanamento “[….] l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio”, per modificare la sagoma dell’edificio. Siamo passati in maniera anodina a parlare di edificio e non più di organismi edilizi. Altro punto (molto) critico è la non coincidenza del sedime. Il sedime è infatti l’impronta a terra dell’edificio, da non confondere con l’area di sedime, tra l’altro. Ma se non devo necessariamente insistere sulla stessa impronta, se non è previsto almeno un punto di contatto, se non è fissata una distanza, si capisce come questa facoltà tenda a far sfumare la nozione verso la ristrutturazione urbanistica. Anche se per me esistono delle differenze che illustro meglio più sotto. Posso immaginare che il limite naturale a cui pensa il legislatore nazionale sia la superficie fondiaria del lotto e soprattutto la coincidenza di destinazione urbanistica. Sono tuttavia mere intuizioni, al momento non suffragate da alcun documento ufficiale.]
4. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. [La parola “altresì” è ampliativa ed è simile a “anche”. E “anche” è una facoltà insomma, e non un obbligo. L’intervento può prevedere anche incrementi di volumetria, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Questi incrementi non sono insomma necessariamente legati a interventi di rigenerazione urbana.]
5. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. [L’avverbio “eventualmente” mette in allerta: si tratta di un fatto legato a un evento? Di un evento che esclude la volontà? Lo stesso avverbio è collegato al solo crollo e non anche alla demolizione? Si ripropone anche qui il dilemma tra il tutto o una parte, seppure con incidenza diversa dai periodi precedenti. Altra differenza notevole su cui sorvoliamo spesso, credo: quella tra ripristino e ricostruzione. Sono a mio avviso due cose logicamente distinte. Il ripristino è l’operazione con cui riporto un oggetto allo stato precedente, con cui normalmente tolgo un qualcosa che è stato aggiunto. E’ un’operazione cronologicamente successiva a un intervento già eseguito. Possibilmente eseguito da poco tempo, il che consente di avere perfetta contezza dello stato ex ante. Nelle Ordinanze di “Demolizione e rimessa in pristino” chiediamo infatti e appunto ai destinatari di riportare la situazione dell’oggetto allo stato in cui era prima. La ricostruzione è invece un’operazione con cui appunto ricostruisco qualcosa, aggiungo qualcosa a uno stato attuale che è lacunoso. Ricostruisco un ginocchio con una protesi, o un dente con una pasta termoindurente, per esempio. Ricostruisco un qualcosa di cui posso aver perso anche la memoria, di cui ho cognizione della sola “consistenza”, come dice la norma, ma non anche dei prospetti o della sagoma. E invece il periodo 5) dice una cosa diversa e contraria alla mia argomentazione. La ricostruzione è qui concetto strumentale, funzionale, servente, rispetto al ripristino. Insomma: per il legislatore ripristino se ricostruisco. La condizione è che sia possibile accertarne la consistenza. Vedremo che nel periodo 6) questa polarità “ricostruzione-ripristino” riemerge con valenza diversa.]
6. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
[Periodo terribile, che provo a riscrivere qui sotto. 6. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 6.1 Fanno eccezione rispetto alla disposizione del periodo precedente gli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo. 6.2 Rimane fermo inoltre che con riferimento agli immobili elencati di seguito gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria: a) nelle zone A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, b) in zone assimilabili alle zone A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali; c) nei centri e nuclei storici consolidati; d) negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico. 6.3 Previsioni legislative o strumenti urbanistici possono disporre diversamente sui casi elencati nel periodo precedente.
Ci sono moltissime cose da dire. Innanzi tutto: perché il primo periodo non viene espresso in forma positiva? Si poteva dire forse: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. [….]” E ancora meglio: “Rimane fermo che, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 136, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. [….]”. Di fatto questa è la lettura sostanziale che bisogna fare. Perché dunque questa diversa maniera di scrivere? A mio avviso perché ci sarebbe una riduzione del campo di applicazione a cui il Ministero non vuole rinunciare. E la riduzione passa attraverso l’introduzione della parola “edifici” dopo aver detto, in apertura, di far riferimento agli “immobili” sottoposti a tutela dal Codice dei Beni Culturali. La categoria “immobili” è infatti più ampia della categoria “edifici”, e comprende manufatti, terreni, parchi, ecc.
Provo a riscriverlo ancora: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. Rimane fermo inoltre che, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”
- Attenzione alle differenze a cui accennavo poco sopra tra ricostruzione e ripristino. E qui abbiamo due interventi diversi, logicamente diversi, che sono tornati ad avere pari dignità: nessun concetto è servente rispetto all’altro. Il primo è quello di “demolizione-e-ricostruzione”. Il secondo è quello di “ripristino-di-edifici-crollati-o-demoliti”. Ma se la ricostruzione era concetto strumentale rispetto al ripristino, come al periodo 5, perché non dire semplicemente “gli interventi di ripristino di edifici crollati, demoliti o da demolire …”? A mio avviso si è voluto ancora segnare una differenza sotto il profilo soggettivo e sulla volontà dell’atto demolitorio. L’intervento di demolizione-e-ricostruzione implica una volontà precisa, volta ovviamente alla ricostruzione, di cui la demolizione rappresenta solo un passaggio obbligato. Gli altri edifici sono pervenuti a noi già demoliti o crollati, per i quali potremmo non avere alcuna responsabilità. Ma sotto il profilo della gestione quotidiana poco cambia per noi. Faccio notare poi altre differenze. L’avverbio “eventualmente” è stato espunto dalla frase: gli edifici sono crollati o demoliti, senza “eventi”. Così come non c’è più la parzialità degli edifici, ma solo la totalità, il che apre un tema enorme, a mio avviso. Se infatti la disposizione vale solo per edifici presi nella loro totalità e se la differenza tra la parte e il tutto non è mai definita, la disposizione non si dovrebbe applicare per le demo-ricostruzioni parziali o per ripristini parziali. Il che consentirebbe, in buona sostanza, di evitare tutte le condizioni di “fedeltà”: sagoma, sedime, ecc.
- Qui purtroppo bisogna fare l’operazione ermeneutica inversa a quella che abbiamo fatto prima e dire che la costruzione del primo periodo deve intendere la virgola come congiuntiva. Non facile, scritto male, ma non mi pare ci sia altra lettura. Per semplificare ancora: devono essere congiuntamente mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Anche perché sarebbe impossibile mantenere gli stessi prospetti e sagoma facendo variare le “caratteristiche planivolumetriche” (che comunque non si sa cosa siano). Impossibile avere incrementi di volumetria e non variare la sagoma, per esempio. È una congiunzione obbligata nei fatti prima ancora che nel diritto.
- La parte finale del periodo pone ad ogni modo qualche ulteriore riflessione. Se infatti il punto 6.2.b tutela le zone assimilabili alle zone A del DM 1444/1968 (leggi: i centri storici), a cosa si riferisce il punto 6.2.c? Se il PRG non ha definito i nuclei storici consolidati (punto 6.2.c), o ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico (punto 6.2.d), a mio avviso la norma non ha effetti.
Passiamo ora a vedere la nozione di ristrutturazione urbanistica del DPR 380/2001, che costituisce, come abbiamo detto, il “limite superiore” della ristrutturazione edilizia.
f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
[La nozione prevede la sostituzione di un pre-esistente tessuto urbanistico edilizio, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi (quindi dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione), anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Anche è, come sempre, una parola ampliativa: indica una facoltà. Non c’è bisogno insomma che ci sia anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale per rientrare nella categoria di ristrutturazione urbanistica. Sarebbe sufficiente insomma avere un insieme sistematico di interventi edilizi. Ma anche a voler accordare una lettura congiuntiva della frase, a me pare che la ri-localizzazione di un singolo edificio non possa essere definita di ristrutturazione urbanistica, soprattutto se rimaniamo nello stesso fondo o comunque nella stessa zona urbanistica.
In prima battuta è bene ricordare che la nozione di ristrutturazione urbanistica fa parte della tassonomia prodotta dalla L. 457/78, rubricata “Norme per l’edilizia residenziale”, in un quadro culturale, sociale e operativo (con la legge furono introdotti strumenti finanziari molto significativi), che puntava a dare risposte al tema dell’alloggio e della casa ai ceti meno abbienti. La legge era poi incentrata nulla necessità di recuperare e rigenerare, come si direbbe oggi, il centro storico, uscito dalla seconda guerra e dalla pressione insediativa del boom in condizioni pessime. Questa brevissima digressione è necessaria per capire la genesi della nozione, che affronta il tema urbanistico (leggi: la città consolidata), si rivolge a “tessuti” urbanistici-edilizi, immagina lotti e isolati. Non pensa al recupero dell’annesso agricolo, perso nello spazio rurale. E’ la Regione Umbria che modifica la nozione di ristrutturazione urbanistica introducendo due modifiche (in neretto). Ecco la definizione della LR 1/2015: “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale”. La modifica mi sembra andare oltre il consentito (vedi per tutte la Sentenza di Cortina sulla riserva statale in tema di definizioni degli interventi), ma non è questa la sede per discutere di questo punto. Il tema è qui, semmai, quanto risulti difficile definire tecnicamente cosa sia un tessuto rurale. Nell’urbano abbiamo un tessuto fatto di elementi alla scala adeguata: case, lotti, strade, parcheggi, piazze, ecc. Nello spazio rurale io trovo difficile parlare di “tessuto”. E’ evidente che la Regione Umbria tenti una distinzione tra la nozione di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante e la nozione di ristrutturazione urbanistica, cercando di limitare i danni di un possibile decollo e atterraggio di edifici, senza limiti di distanza, posti nello spazio rurale, se si interpreta in maniera estensiva la ristrutturazione edilizia.
Registriamo infatti sulla ristrutturazione edilizia “pesante” due atteggiamenti culturali diversi nel legislatore e anche nell’organo giudiziario.
Da una parte vi è un occhio di favore nel guardare la ristrutturazione pesante come ristrutturazione edilizia perché favorisce le operazioni di rigenerazione e sfavorisce (così sembra), le operazioni di consumo di suolo. Ma anche qui sarebbe più corretto distinguere tra consumo di suolo e consumo di capacità edificatoria, tant’è vero che possiamo avere operazioni di demolizione e ricostruzione in pareggio di capacità edificatoria ma non necessariamente in consumo di suolo. L’altro atteggiamento è di chi vede nella ristrutturazione edilizia pesante un’operazione che è di fatto un’operazione di ristrutturazione urbanistica.
La nozione, come abbiamo visto, è schiacciata da sotto e da sopra e oggi è di grande attualità anche a causa dei vantaggi fiscali, derivanti da leggi che appartengono ad altre logiche (Legge Tupini, ecc.). La ristrutturazione edilizia deve (dovrebbe), tenere in equilibrio la nozione di ristrutturazione in sé, il consumo di suolo, il consumo di capacità edificatoria, i risvolti civilistici nella ricostruzione (problema delle distanze preesistenti), il sistema dei vantaggi fiscali. Il tutto distinguendo tra aree vincolate e non vincolate. Mi sembra evidente che il compito è di difficile risoluzione e che una sola nozione non riesce più a cogliere il fenomeno: i giudici faticano sempre più e le Regioni non aiutano, producendo ognuna una propria declinazione di concetti che dovrebbero essere invece rimanere fermi per tutti. Regioni e Stato dovrebbero concorrere e produrre una nuova tassonomia degli interventi, traguardando le diverse finalità degli stessi.]
Paesaggio e architettura*
Farò un intervento un po’ per punti, per nodi critici, al limite anche iconici e provocatori. E poi lascio delle domande sul tavolo. Dati i limiti di tempo e il tavolo di relatori e il parterre, credo che sia l’atteggiamento giusto. Ritengo che dobbiamo pensare ad alcune date significative che riguardano il paesaggio per poi chiudere sull’architettura.
1) Il paesaggio è per me come il tempo per sant’Agostino. Tutti sappiamo cos’è, ma non lo sappiamo definire. E noi abbiamo già difficoltà a definire le cose limitate, figuriamoci quelle illimitate, quelle di cui è difficile tracciare un confine, una cornice, un recinto. Tuttavia, per parlare e per far aumentare la conoscenza, dobbiamo convenire su alcune definizioni. Parto forse da quella più banale, più prosaica, meno poetica: la Convenzione Europea del Paesaggio. La Convenzione Europea che tutti conoscono, non aiuta: lo dico con modestia e con il gusto di provocare un po’. L’art. 1 della convenzione del 20 ottobre 2000, apre così: “Ai fini della presente Convenzione:
a. “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;”. All’art. 2 continua poi così: “Articolo 2 – Campo di applicazione.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.”
I profili critici di questa definizione sono stati evidenziati da autori enormemente più prepararti di me sul tema. Ne voglio ribadire, solo per esigenze di memoria, e per esigenze che poi attengono alla gestione pratica del paesaggio, solo alcuni: il paesaggio designa una determinata parte di territorio. Il punto è come definire, delimitare una parte. Dove finisce questa parte? Come è percepita dalle popolazioni? Quali? In che modo capiremo come sono percepiti? Il carattere di un paesaggio che cosa è? Già il tema del “carattere” in architettura ha preso molte nostre energie: definire oggi il carattere di un paesaggio è sfida intellettuale e culturale improba.
L’art. 2 aumenta ancora la difficoltà, poiché se tutto può essere paesaggio, tutto è paesaggio. E’ evidente dunque che c’è bisogno di una costruzione valoriale e di una governance specifica per l’attribuzione o il riconoscimento di detti valori.
Posso provare a definire il paesaggio per via negativa, cercando di eliminare le “incrostazioni” dal concetto. E io ne vedo 3.
a) Il paesaggio non è l’ambiente. Anche se vi è stato un notevole schiacciamento tra i due termini, direi che l’ambiente è base nuda, lo sfondo, la matrice (come direbbero gli ambientalisti), su cui il paesaggio si fonda.
b) Il paesaggio non è il territorio. Il territorio, luogo forse privilegiato dagli urbanisti è il dato asciutto: al massimo è il luogo dove prevedere, con sovrastimate capacità demiurgiche, la localizzazione di ferrovie, strade, case, scuole, campi.
c) Il paesaggio non è il panorama, soprattutto se vogliamo superare quella concezione “visibilistica” o solo visibilistica del paesaggio. È una relazione strana: ogni panorama è sicuramente un paesaggio. Non necessariamente il paesaggio è un panorama. Pensiamo per esempio a un paesaggio urbano, un paesaggio industriale, una grande radura nel bosco, per usare un’immagine cara ai filosofi.
Conoscete questa frase della scuola di palo Alto: “È impossibile non comunicare”. Tradotto nel nostro contesto vuol dire che è impossibile non essere in un paesaggio. il paesaggio è già un significato. Noi siamo sempre in un paesaggio, solo che non lo sappiamo dire.
2) 470 a.c. Il tuffatore di Pompei. È un’immagine molto nota. Vi sono state molte letture di questa immagine: il passaggio dalla vita alla morte, lo sguardo verso il futuro, il fatto che sia solo un tuffo. A me piace pensare che questo tuffo segni il passaggio culturale del mare visto prima come territorio e ora come paesaggio. Se infatti diciamo tutti che bisogna superare la concezione solo “visibilistica” del paesaggio a favore di una concezione più estetica (nel senso greco del termine: della percezione, dei sensi), beh allora credo che questa immagine sia emblematica. Il mare smette di essere l’elemento che fa paura e diventa un elemento di piacere. Vado al mare non solo per pescare (territorio), ma vado al mare per tuffarmi. Il mare non mi mette più paura: posso anzi avere il gusto di salire su una scala, un trampolino, per lanciarmi e lasciarmi avvolgere dalla sua freschezza, dalla sensazione di scivolare sull’acqua. Chi sa nuotare sa a cosa mi riferisco, a quella sensazione di essere uno con l’acqua, di essere nel flusso, di scivolare in un elemento amico.
3) 1339. Il buongoverno. Il paesaggio buono è bello. L’estetica contemporanea ha fatto saltare il collegamento tra ciò che è buono e ciò che è bello. Umberto Eco ha scritto l’elogia della bruttezza e la categoria del brutto è entrata nelle nostre discussioni come argomento piacevole di conversazione. Solo che la piacevolezza decade immediatamente se siamo immersi in un luogo brutto, e massimamente se quel luogo brutto si associa alla nostra sicurezza. Il brutto è bello (passatemi l’espressione), solo se è visto da lontano. Il deserto è bello solo se visto dall’aereo e non se sto morendo di sete mentre cerco una strada, un’orizzonte amico, un’oasi. L’inverso invece non è dato, anzi. Il paesaggio bello ci rende più buoni. Proverbio danese. Con il generale Benedetto parlavamo prima davanti al caffe. Quant’è bella la nebbia vista da montefalco! Quant’è brutta se ci rituffiamo dentro.
4) 1353. L’ascesa al Monte Ventoux di Petrarca. L’ascesa è un’ascesi. Scoprire il paesaggio è (anche) scoprire se stessi. Il paesaggio è quel luogo paradossale e contemporaneo di due movimenti apparentemente antinomici tra loro: uno verso l’esterno, verso l’orizzonte, un’estasi, e l’altro verso l’interno, un insight. Anche qui il rapporto con il territorio (dove vado a pascolare le capre, a tagliare la legna), è diventato un rapporto di altro tipo. Io vado sulla montagna per sentirmi uno con la montagna. O per sentirmi diverso da tutto quello che vedo, o immagino, nella valle. Direi che l’ascesa del Petrarca è il racconto del tuffatore, o meglio del nuotatore.
5) 1837. Leopardi. «Una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili, eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme; è cosa artificiata, e diversa molto da quella che sarebbe in natura»
Leopardi
6) il 1969 è un anno fantastico per il paesaggio. Il 21 luglio 1969 Il nuovo paesaggio è tutta la terra. Lo era già stato con la prima fotografia dall’orbita lunare di Apollo 8 verso la Terra. Ma ancora di più con lo sbarco sulla Luna è la Terra che diventa il nostro paesaggio. La Terra intera diventa un unico paesaggio. Così come la Luna. In un unico momento abbiamo due paesaggi folgoranti e forse ce ne rendiamo conto solo dopo.
7) Il 29 ottobre 1969 due computer si scambiano un messaggio, o meglio due uomini si mandano un messaggio attraverso due computer. Nasce il web, di fatto. Non sembri una banalità, ma la rete fa nascere un nuovo paesaggio, perché del paesaggio riesce ad eliminare il dato territoriale: la distanza. Il paesaggio fino ad allora condivideva con il territorio un parametro di riferimento geografico vorrei dire, un parametro comune, un parametro “simmetrico” avrebbe detto Aristotele: la distanza. La rete fa saltare questo rapporto e la Terra è diventata velocissima. Uno dei parametri che faceva accomunare paesaggio e ambiente, paesaggio e territorio, è la distanza, la distanza fisica. Che qui tende a scomparire, a farsi incommensurabile.
8) 1992. Il metaverso. Il prossimo paesaggio è quello del metaverso. Il metaverso, poliverso ecc. fa saltare anche altri parametri che sono quelli della realtà della visione e della percezione. Chi ha provato gli occhiali e le applicazioni di realtà aumentata o di realtà virtuale sa che cosa si prova. La sensazione fisica di essere in un mondo reale, altrettanto reale è fortissima. E siamo solo agli inizi. È sicuro che nel futuro prossimo, immediato avremo un ampliamento protesico, o endoprotesico, delle nostre percezioni. Ma quali categorie estetiche possiamo applicare a questo mondo? Sono ancora valide? Ne dobbiamo trovare delle altre?
9) Creare spazio. La frontiera culturale che ci attende è quella di creare spazio. Anche se potessimo immediatamente diventare tutti virtuosi, oramai ci dicono che abbiamo già consumato il nostro pianeta. Io non sono un fanatico di questo dogma del consumo di suolo, dato che va sempre ben temperato, altrimenti si rischia di fare confusione. Abbiamo consumato spazio in Italia, ma negli ultimi 20 anni sono cresciuti anche i boschi. I boschi sono luoghi molto più naturali dell’agricoltura. Oggi l’agricoltura intensiva è un’officina, una grande officina, i cui salariati hanno le radici nel campo. Detto ciò, noi non possiamo fare altro che creare nuovo suolo, nuovo territorio, perché non è riducendo di qualche ettaro i nostri piani regolatori che salveremo il pianeta. Il nuovo suolo è dato dalle vertical farm, dal coltivare il mare, dal creare proteine di sintesi, da coltivare nello spazio, dal colonizzare satelliti e altri pianeti. Dico questo non perché mi faccia particolarmente piacere, ma perché i nostri amici ambientalisti mi dicono che siamo già in ritardo.
10) E l’architettura? I nodi tra architettura e paesaggio sono molteplici. Tuttavia oggi voglio usare il paesaggio per ragionare sulla differenza tra progetto e restauro. Se quello che dice Leopardi è vero, se quello che dice la Convenzione del Paesaggio è vero, se si assume un’ottica attenta al paesaggio, la differenza tra il progetto del nuovo e il recupero dell’esistente tende a scomparire. Non c’è mai un nuovo progetto: il foglio non è mai bianco. Qualche anno fa, quando insegnavo all’università, mi capitavano studenti che dicevano di aver il blocco del foglio bianco. Innanzi tutto il foglio è bianco perché non hai una teoria. E il foglio bianco in sé non suggerisce nulla, anche se continui a guardarlo per molto tempo. E la prima teoria dovrebbe essere questa: che è impossibile non essere in un luogo, in un paesaggio. Noi siamo sempre in un paesaggio, e la costruzione della nostra nuova villa (il sogno di ogni architetto), non è altro che il restauro di una costruzione più ampia che si chiama luogo: paesaggio, appunto. Siamo a Montefalco: pensiamo per un attimo di dover intervenire sul “Fungo”. Si tratterebbe di sola architettura? O non invece di paesaggio? E nel momento in cui lo si è costruito, si è costruito solo un nuovo oggetto architettonico, o si è modificato (significativamente), sul paesaggio? Ovviamente uso qui la parola restauro in un’accezione che è impropria: solo per contrapporla al progetto ex-novo. E se non c’è un paesaggio, che per me è sempre una costruzione intellettuale e quindi simile concettualmente all’architettura, c’è almeno un territorio, un ambiente: il sole, i venti dominanti, l’esposizione, l’umidità, ecc. C’è sempre qualcosa da cui partire. C’è sempre troppo da cui partire: la realtà è spesso sovrabbondante, per chi sa guardare. La difficoltà è semmai nello scegliere la giusta partenza, la giusta distanza.
* Traccia dell’intervento tenuto a Montefalco il 25 novembre 2022, invitato da Fondazione Sorella Natura
E27(2)
“[….] una rete di mobilità dolce [….]”
Bisogna tornare a nominare le cose come sono, che è un grande sforzo di umiltà e di realtà. Per mobilità dolce si intende un percorso per biciclette e altri mezzi? I marciapiedi sono già mobilità dolce? I percorsi per le biciclette devono essere necessariamente asfaltate? Devono essere necessariamente delle piste da corsa? Perché ricordo che la bicicletta è un mezzo previsto dal codice della strada che dovrebbe andare sulla strada. Perché questi percorsi non possono farsi con del semplice ghiaino (permeabile, tra l’altro)?
“[….] un tessuto continuo di prati e campi incolti [….]”
I campi incolti sono il segno della disfatta di un’iniziativa economica: non sono lì per fare da connettore ecologico tra altri prati e giardini. Per il semplice motivo che nessuno paga l’agricoltore per realizzare dei connettori ecologici. Se si vogliono dei connettori di questo tipo, se la collettività ritiene che questi connettori siano un valore fondamentale, la stessa collettività deve essere in grado di pagare per questo valore. Così come i prati. I prati sono tali perché sono destinati al pascolo o allo sfalcio, e non alla composizione estetizzante di patchwork visibili dall’alto di una terrazza (naturale o meno).
“[….] un parco multifunzionale [….]”
Che cos’è un parco multifunzionale? A cosa potrebbe formalmente rassomigliare se non alla città dispersa che tutti (apparentemente) disprezzano? Un parco è un ambito piuttosto esteso dove la matrice predominante è rappresentata da spazio agricolo (che oggi è tutto meno che naturale). E in questa matrice abbiamo una punteggiatura di casolari e agriturismi. E da un punto di vista formale vorrei capire che cosa cambia tra un agriturismo e uno studio dentistico o ambulatoriale, tra un casolare con le stalle e una piccola officina per riparare trattori o macchine o biciclette. E se non c’è una grande differenza, come immagino, bisogna accettare che in fondo questa città dispersa in Umbria, in Italia, non è tutta da disprezzare. Se non è multifunzionale è spazio rurale, come l’abbiamo sempre conosciuto e vissuto.
E27(1)
E27 (1)
La serie E27 vuole essere una serie di piccole notazioni critiche negli ambiti che più mi interessano: l’architettura, l’arte, la letteratura, il cinema …
Questa nasce dall’insofferenza che mi prende quando leggo testi sistematici o relazioni illustrative di piani, strumenti, programmi, redatti per la maggior parte da colleghi architetti in tema di pianificazione. Urbanistica, ma anche ambientale o di settore.
Molti di questi redattori sono colleghi, e qualcuno anche amico: se l’amicizia se è tale, forse potrà ben sopportare qualche critica. Non me ne vogliano, insomma: sono disponibile alle loro repliche.
Ritengo che l’uso di questo linguaggio dimostri una conoscenza superficiale delle dinamiche economiche e sociali (in buona fede). Sul territorio agricolo si sentono e si leggono poi delle cose che riflettono una visione ideologica del mondo (ideologica nel senso di non realistico), del tutto lontane dal mondo produttivo agricolo. Lo dico da uomo cresciuto in campagna e ancora e sempre vicino al mondo rurale.
Riporto per cominciare un passo e una locuzione abusata e le commento.
“[….] impostare un percorso di aggregazione volontaria ed attiva di attori del territorio attraverso patti di collaborazione per avviare un programma di promozione e sviluppo dell’area tra amministrazione comunale, imprenditori agricoli, strutture ricettive e cittadini. Una governance ‘leggera’ che assume la forma di network di coordinamento di iniziative comuni senza spese di gestione.”
CHI dovrebbe impostare un percorso di aggregazione “volontaria”? Che cosa è una governance leggera senza spese di gestione? Le cose si realizzano perché qualcuno decide. E in organizzazioni appena un po’ più complesse della tirannia il procedimento di decisione va formalizzato. E la formalizzazione implica una struttura, dei ruoli, delle responsabilità, degli impegni. Altrimenti è un happening, un flash-mob, un aperi-cena (che parola!). Occorrono patti, contratti, firme: quello che già conosciamo. Non è la forma di queste associazioni il problema: il problema sono i contenuti. Ci mettiamo insieme per fare cosa? Quali sono i nostri obiettivi comuni? Quali sono i nostri valori? Quanto siamo disposti a pagare per averli?
I prodotti a Km zero.
Un mercato di prodotti a Km zero è quasi la negazione ontologica del mercato, che nasce per far incontrare merci che arrivano (anche) da lontano. I prodotti a Km zero significa avere prodotti (anche), a Ore zero: nel senso della vicinanza e della freschezza. Ma anche nel senso dell’adesione ai cicli naturali. Prodotti a Km zero a Milano significa non avere ananas a Natale o più banalmente arance, o banane, per esempio. Significa che le fragole arrivano a maggio e non a settembre. Significa che le ciliegie arrivano a giugno, non a febbraio. Siamo disposti a questi sacrifici? O per prodotti a Km zero parliamo solo di lattughe e ravanelli? Perché se è così non credo che potrebbe contribuire in maniera significativa a risolvere o mitigare i nostri problemi ambientali.
