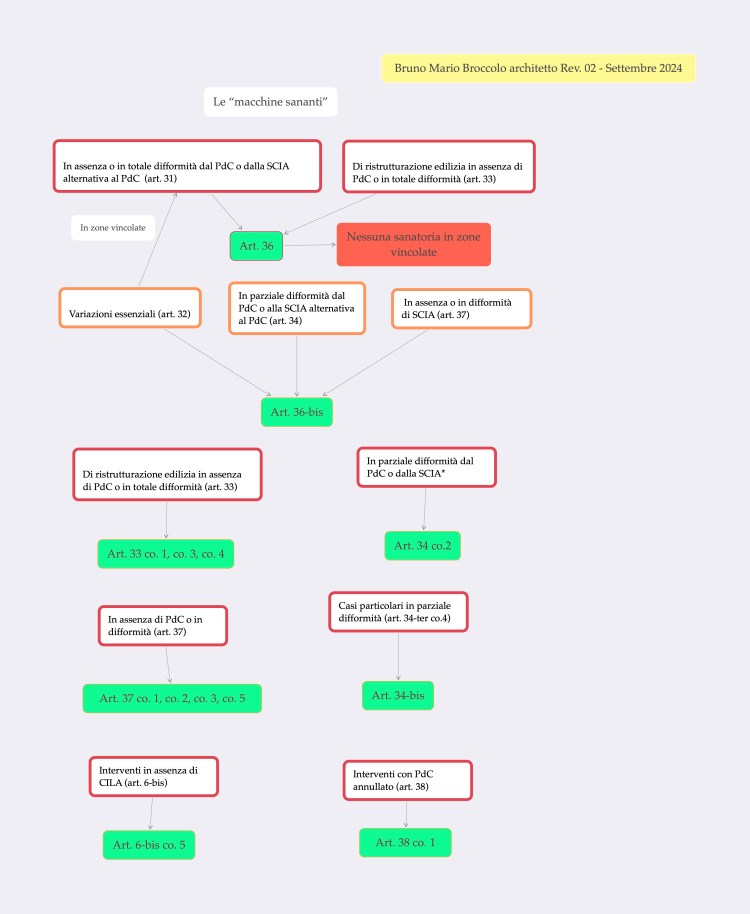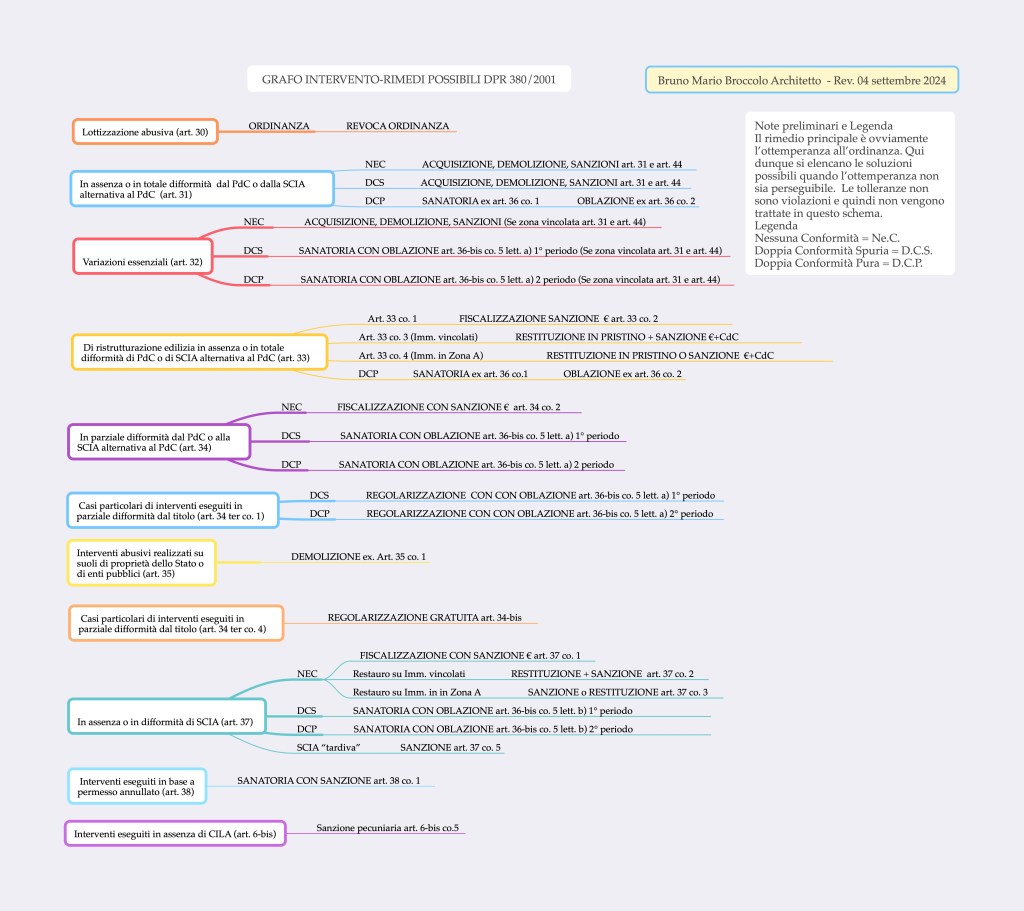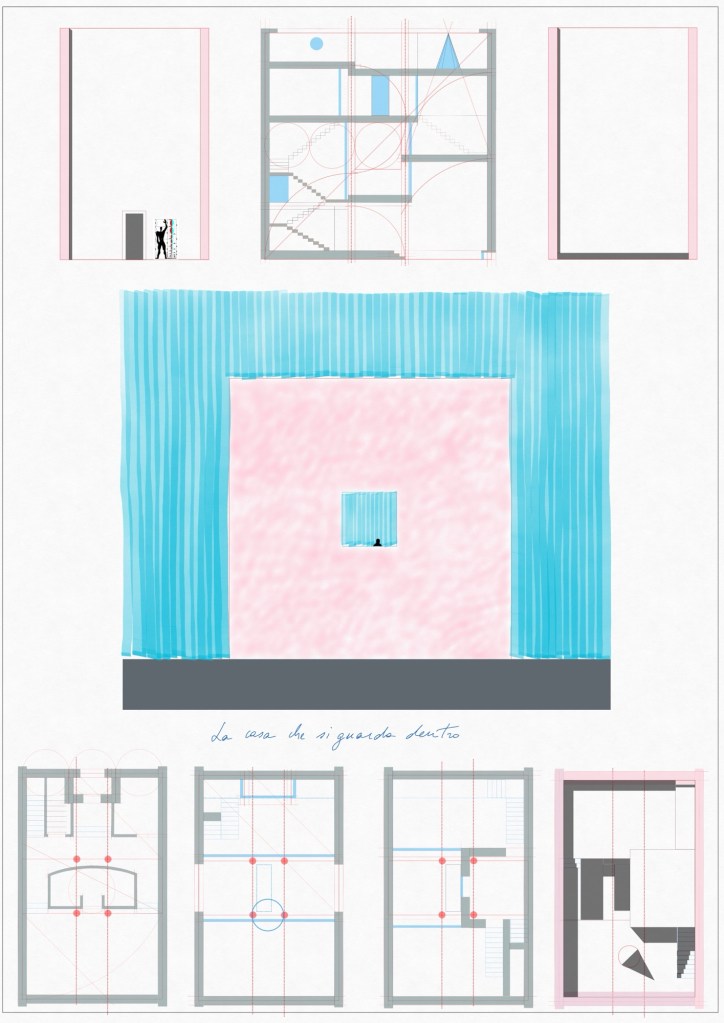In questo terzo blocco parlerò di alcuni interventi possibili, come anticipato nel primo testo. Posso solo proporre sinteticamente alcune idee, che hanno bisogno di una ponderazione tecnica e di una critica più analitica. Come solito, sono alcuni spunti, magari più approfonditi dei soliti che vediamo sui social, che vogliono essere un contributo alla discussione. Non sono idee sistematiche. In qualche passaggio potranno apparire pensieri provocatori o controintuitivi. Forse portano più dubbi che risposte: bene così. Non amo le posizioni ideologiche, e non amo nemmeno l’eccesso di sperimentazione e di ricerca, che lascio all’Università, sede elettiva che, come i miei amici sanno, ho frequentato per diversi anni. Il mondo reale ha bisogno di buone idee ambiziose, ma praticabili: il bastone deve essere lanciato abbastanza lontano, ma non in orbita, come sa chi ha un cane con cui giocare. Dunque, ecco vari (s)punti.
Accordo di copianificazione con Assisi e Perugia
Ritengo che innanzi tutto via sia una questione di metodo da porre sul tavolo e cioè l’impossibilità oggi di redigere un PRG senza allargare l’ottica ai Comuni limitrofi. Nel caso di Bastia Umbra (5 km di diametro circa), sembra poi una necessità assoluta. E’ evidente che i Comuni a cui bisogna guardare subito sono Assisi e Perugia.
Con Assisi dobbiamo dialogare per integrare le due rispettive zone industriali a sud della SS75, che di fatto possono costituire un unico distretto. Ma questo non per renderle ancora più monotematiche, ma anzi per farle diventare un terzo polo cittadino della città che ormai E’ lineare: Assisi-Bastia. Ritengo infatti che le zone cosiddette industriali possano rappresentare la vera città dei prossimi decenni. Le produzioni che vi si fanno sono pochissimo inquinanti oggi, e sono completamente integrabili con la residenza. Sono zone generalmente ben infrastrutturate (strade, sottoservizi, ecc.), dove la rigenerazione sconta un basso valore sedimentato sul fondo (demolire un prefabbricato di un piano non è un onere insostenibile), e dove dunque sarebbe facile ricostruire con un incremento di valore. Sono già brown-field e quindi non si consuma altro suolo. Sto parlando, come detto, ovviamente di produzioni compatibili con la residenza: è evidente che le ARIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante) o insalubri dovranno essere collocate in aree idonee. Sono aree molto “plastiche” sia sotto il profilo fisico che dell’uso, e possono essere trasformate in aree verdi, in residenza, in servizi: in città.
Queste aree potrebbero essere benissimo le aree di atterraggio di molte quantità edificatore in decollo, con una fattibilità economica facilmente verificabile.
Volendo ancora continuare nell’uso più produttivo è certo auspicabile che le aziende che insistono nel nostro territorio cerchino di formare un ciclo chiuso per essere il più ecologico possibile. Tuttavia le logiche del mercato non sempre ricalcano quella dell’economia più pronta. E non sempre ciò che appare il più ecologico lo è (altro motivo per cui non sono un fan della partecipazione, a cui molti arrivano basandosi su notizie parziali o addirittura false). E allora potremmo pensare a un grande centro di scambio modale per portare le merci all’interno dei nostri centri storici (Assisi, Bettona, Torgiano, Brufa), con mezzi più leggeri e meno inquinanti.
Con Assisi dobbiamo parlare della viabilità e del cosiddetto Parco Agricolo. E soprattutto dobbiamo parlare dell’aeroporto.
Sulla viabilità c’è un tema d’attualità che è quello del sovrappasso della ferrovia in prossimità di Ospedalicchio, verso l’aeroporto, verificato che il sottopasso pone immensi problemi realizzativi. Tra l’altro il sovrappasso consentirebbe una libera e magnifica vista su Assisi. E poi c’è il tema di un collegamento all’altezza di Mezzomiglio.
Infine il tema dei temi (per me): Via Roma. Chi mi conosce sa che penso da tanti anni a Via Roma come a un asse da densificare ancora, in modo da farla diventare la più bella via dell’Umbria e oltre. Una Via che penso si potrebbe chiamare Strada Aurea, in onore soprattutto a Galeazzo Alessi. Una via costellata di episodi urbani (arte), parcheggi attrezzati, negozi, servizi, di spazi aperti per piccoli concerti.
Con il Giubileo arriveranno ad Assisi forse 20 milioni di turisti: non è pensabile che non ne intercettiamo che una piccolissima parte. Certo siamo già in ritardo: magari per il prossimo Giubileo riusciremo a fare qualcosa di più. Sarebbe molto bello pensare a un percorso pedonale e ciclabile che vada da Assisi a Roma, seguendo il Tevere e passando per Bastia Umbra. E poi non è più solo un turismo religioso: Assisi è diventata e sarà sempre più il palcoscenico di eventi dedicati all’ambiente, alla pace, alla spiritualità in senso lato, ecc. Dobbiamo pensare di intercettare una parte di questo transito e offrirgli dei servizi adeguati.
Tra l’aeroporto e Assisi per esempio è possibile pensare a un percorso (anche a più di uno, a dire il vero), ciclabile, che attraversa Bastia Umbra. E così verso il Tevere a Ponte San Giovanni, passando per Ospedalicchio.
Ma con Assisi e Perugia dobbiamo parlare soprattutto di quella che io etichetto come una “Nuova Porta dell’Umbria”: l’uscita dalla galleria San Gregorio della SS 318, proveniente dalle Marche, apre verso uno scenario di sviluppo che non può essere lasciato inesplorato, a due passi dall’aeroporto. Uscendo da questa ultima galleria si arriva in Umbria da est: una nuova porta, di rango territoriale, che interessa Perugia Assisi Bastia. Certo, è un tema da pianificazione regionale. Nell’attesa, sarebbe meglio cominciare a fare dei ragionamenti. L’aeroporto va potenziato (non dipende solo da Bastia, ovviamente), e va soprattutto capito quali servizi la città di Bastia può offrire a chi arriva all’aeroporto, che per buona parte si dirige verso Assisi e verso Perugia. E’ possibile arrivare con la ferrovia fino all’aeroporto? Possibile un dialogo con Perugia, invece di avere un servizio navetta fino all’Ipercoop di Collestrada.
Una città non può vivere senza la propria economia. Anche in questo caso Bastia sembra soffrire una sorta di “timore” nel rivendicare la propria vocazione commerciale e produttiva. Al di là della qualità del progetto, l’ingresso di Bastia con la Coop e Mc Donald’s, a me pare migliorata rispetto a prima. Si poteva fare meglio? Probabilmente sì. Ma ripeto, al di là di questo progetto, la nuova area funzionerà da catalizzatore per altri interventi di riqualificazione.
Bastia ha una bella zona industriale: occorre integrarla con un’economia di servizi. Per esempio il Centro Fieristico dovrebbe essere molto più a servizio delle aziende vicine.
Rigenerazione grandi aree
Le aree che hanno bisogno di riqualificazione sono rimaste ferme, se si eccettua una parte della zona (ex) Franchi. Piazza del Mercato è ferma e oramai sono da considerarsi come aree di riqualificazione anche l’area produttiva Mignini Petrini (con l’incognita del vincolo della Soprintendenza di cui ho parlato nella seconda parte). Dove e come delocalizzare le Officine Franchi? In quali aree? Con quali finanziamenti? Lasciarle lì e cercare di re-integrale in un nuovo progetto?
Occorre trovare altri fondi e una progettazione di qualità: o attraverso un nome che sia una garanzia inappellabile o attraverso un concorso di architettura, con i soliti sub-problemi dei concorsi (chi lo indice? Chi paga la commissione? Chi decide? Ecc.)
Ma poi cosa dovremmo dire di più su queste aree di rigenerazione? Oramai abbiamo capito tecnicamente cosa può essere fatto. Credo che sovrastimiamo il potere della forma, della composizione architettonica (in questo caso della composizione urbana). Il problema di queste aree non è il disegno urbano: è il mix delle destinazioni d’uso e dunque degli attori in gioco.
L’area di Piazza del Mercato è stata studiata dal 1966 a Bastia Umbra, con la chiamata dei tre “saggi”, e vi partecipò poco dopo anche Leoncilli Massi, appena laureato. Poi una lunga serie di proposte e di architetti, tra cui ricordo (forse dimenticando qualcuno): Adriano Brozzetti, Vanni Orsoni, Luca Scacchetti, Adolfo Natalini, Pietro Carlo Pellegrini.
Il tema è sempre il montaggio dell’operazione, la composizione della squadra che deve attuare, chi investe, come, ecc.
Il tema è sempre trovare una destinazione d’uso (o meglio: un mix di destinazioni d’uso), che diano una sostenibilità economico-finanziaria all’operazione tutta. Non dobbiamo vedere questa sostenibilità come figlia di un dio minore, perché senza questa nessuna operazione di rigenerazione urbana è possibile. Senza questa vi è solo la degenerazione urbana. L’area Franchi è ferma non per un problema di disegno: è ferma per meccanismi economico-finanziari.
Queste operazioni vengono portate avanti (e soprattutto completate: concluse), se il costo di trasformazione dell’area viene ripagato dal valore di trasformazione. Se l’iniziativa è tutta privata, gli usi previsti sono quelli che rendono di più. Se l’iniziativa è mista dobbiamo capire quanto è disposto a investire il pubblico nell’operazione. Lo dico meglio: quanto siamo disposti NOI a tirare fuori come contributo nell’operazione. Il pubblico siamo noi, parafrasando una canzone spot molto d’attualità.
Queste grandi aree di rigenerazione possono essere anche queste zone d’atterraggio di capacità edificatorie (cubature) in decollo. Purtroppo in questi casi il valore del terreno è alto in partenza, e i costi di demolizione e bonifica sono molto significativi. Il coefficiente correttivo tra decollo e atterraggio deve essere alto per compensare i costi.
Oppure possiamo pensare di reinsediare qualche attività produttiva. In fondo ci sono già attività produttive in essere e nessuno sembra lamentarsi più di tanto. Dunque attività produttive compatibili con la residenza sono altamente possibili. E oggi le attività produttive possono ampliarsi fino a comprendere attività un po’ a cavallo tra servizi e produzione “hard”.
Delocalizzazione detrattori ambientali e paesaggistici
In questo caso credo che il PRG dovrebbe lanciare una call piuttosto che fare dall’alto un censimento (con il rischio di sbagliare e di dover correre ai ripari). E questo potrebbe essere un vero esperimento di partecipazione dal basso. Nel censire questi “detrattori”, il Comune corre infatti più di un rischio, che anche la Regione dovrebbe comprendere. Primo: l’attività è ancora formalmente in essere, anche se momentaneamente sospesa o interrotta. La dichiarazione di “detrattore” fa perdere subito valore al bene. Secondo: nel momento in cui ho censito questi edifici, si presuppone che io Ufficio Tecnico del Comune abbia fatto un minimo di sopralluogo (almeno dalla strada pubblica), e da Google Earth. Nel momento in cui ho fatto il sopralluogo, come pubblico ufficiale, dovrei procedere a verificare la legittimità di quei fabbricati ed emanare qualche ordinanza di demolizione nel caso non fossero in regola. In caso di manufatti illegittimi in aree vincolate (vicino al Fiume Chiascio o nell’area vincolata per consentire la vista del colle di Assisi), si aggiunge un procedimento penale per il titolare. Terzo rischio: potrei averne dimenticato qualcuno. Nel caso dovrei aspettare di fare una variante al PRG specifica per questi accidentalmente esclusi. Quarto rischio: poiché la copertura normativa di questa ricognizione sarebbe data solo da una deliberazione del Consiglio Comunale, mi aspetto una serie importante di osservazioni e anche qualche bel ricorso al TAR.
La premialità necessaria per innescare questi decolli ed atterraggi è purtroppo molto superiore al 30% previsto dalla norma regionale come minimo. E’ sufficiente chiedere una simulazione ad un esperto di estimo per capire che occorrono premi più alti (in una ordinarietà di mercato).
Né si può obbligare ad atterrare in alcuni luoghi precisi e non in altri. Meglio lasciare al caso per caso, citando a (s)proposito Ernesto Nathan Rogers.
Creare con il PRG delle aree di atterraggio (poche), espone l’amministrazione a un rischio poiché istituisce un mercato un po’ forzato, un po’ asimmetrico. Da una parte ha censito (o vuole censire), dei detrattori ambientali, che si vedono dunque il loro valore dimezzato e che sono anche “obbligati” ad andarsene. Dall’altra ha individuato le sole aree dove questi detrattori possono atterrare. A questo punto bisognerebbe introdurre correttivi perequativi, ma al momento non saprei quali e con quale efficacia giuridica.
Ritengo che sia più corretto valutare appunto caso per caso dove questi diritti possano atterrare. Il PRG dovrà premunirsi facendo una carta e una norma indicando solamente quali sono le aree assolutamente indisponibili all’edificazione. Bisogna in qualche modo allargare la platea dei fondi accipienti, e non restringerli. E questo dovrebbe in qualche modo incidere sul fenomeno delle cosiddette ZAUNI (Zone Agricole Utilizzabili per Nuovi Insediamenti), che finché rimangono tali non dovrebbero pagare l’IMU, per esempio.
Visto che siamo anche in tema di immobili nel territorio agricolo, voglio fare un approfondimento, speculare a questo, e che riguarda cioè i beni culturali sparsi nello Spazio Rurale.
Questi beni culturali sparsi non possono risolversi di fatto, per chi vi abita, in ulteriori vincoli. O allora questi vincoli, come succede in altri ambiti (paesaggio, agricoltura, ecc.), devono essere indennizzati. Chi abita ancora in questi casolari deve avere il diritto di modificare le aperture (per avere delle più ampie finestre, ad altezza normale), di modificare l’accesso, senza avere accesso dalle scale esterne, deve poter mettere una parabola: insomma tutto quello che la vita civile oggi richiede. O allora, ripeto, si trovi la formula per indennizzare queste limitazioni. Se ne scelga qualcuna notevole, in numero limitato: per dare conto di un tipo costruttivo non serve aver centinaia di fabbricati.
I cosiddetti “seccatoi” del tabacco, impossibili da ristrutturare secondo criteri conservativi (un tema, per certi versi, e fatte salve le proporzioni, analogo ai silos di Mignini Petrini), pongono paradossalmente ancora più ostacoli. Volendo, anche qui, se ne scelgano pochi notevoli, da tutelare. Sui restanti occorre lasciare un ampio margine di libertà al buon progetto d’architettura. Sul paesaggio non inizio nemmeno la discussione perché ha bisogno di un intervento a parte, che forse farò in seguito.
Centro Storico
La battaglia è persa. Non solo nel caso di Bastia Umbra, ovviamente. La battaglia è persa ovunque: i centri storici si desertificano: di residenti, di scuole, di piccole attività economiche. Il centro storico non può essere visto e analizzato come tema a sé: è solo il nervo più scoperto e sensibile di una progettazione urbanistica (e di una volontà politica, di destra come di sinistra), che ha favorito l’insediamento di grandi superfici commerciali in periferia, che ha ha traslato le scuole in periferia, che ha concesso residenze estensive in periferia. Per riprendersi (una reconquista?), i centri storici occorre pensare a una nuova architettura e a delle nuove forme di incentivazione alla residenza: parcheggi coperti gratuiti per i residenti; la possibilità di modificare il proprio appartamento, il re-insediamento di piccole attività di servizi, il ritorno della scuola, ecc.
Se chi abita nel centro storico non può aprire una finestra, non può mettere un ascensore, non può installare una parabola, deve sottostare alla dittatura acustica della movida, non può andare in banca o in posta a piedi, non può fare un minimo di spesa a piedi, non può andare al cinema, non può accompagnare il figlio a scuola, ecc., credo si possa comprendere perché non voglia più restare.
Riabitare il centro non è più solo questione di pietre, ma di un’azione coordinata di politiche che devono agire su vari fronti: tassazione locale, commercio, sociale, ecc.
Per quello che può essere il lato più architettonico, io credo che si debba avere molto più coraggio nell’affrontare il centro storico e pensare anche a delle operazioni di sostituzione, di demolizione di opere di modesta qualità e di ricostruzione di un nuovo edificio. Certo: forse potremo incappare in qualche errore puntuale: quel nuovo fabbricato appena autorizzato è brutto. Ma l’alternativa a questo rischio è un sicuro lungo dissanguamento e abbandono.
Anche nel caso del Centro storico il Comune può fare molto, mettendo tuttavia fondi in bilancio, e quindi nostri soldi. Può dare al momento incentivi economici per densificare il centro sia di residenti, di commercianti e di professionisti. In attesa di una politica sulla rigenerazione architettonica del centro (demolizioni e ricostruzioni), può essere questo un primo passo.
Mi sia consentita una provocazione, per chiudere sul punto: chi si lamenta che il Centro Storico è vuoto, venda la sua casa e giardino a San Lorenzo o il suo appartamento in Viale Gramsci e acquisti una casa in centro: ce ne sono molte in vendita, a buon mercato.
Qualità prestazionale degli interventi
Come ho anticipato nell’altro testo, la qualità dell’architettura non si lascia ingabbiare da indicatori, parametri, norme, ecc. Tuttavia alcuni standard possono aiutare ad elevare un benessere generale. La modifica del Regolamento Edilizio è l’occasione giusta per introdurre alcuni miglioramenti “prosaici”. Vado in ordine sparso. Ritengo che il covid abbia insegnato che le nostre abitazioni intensive hanno bisogno di essere rese più “porose”, ossia essere dotate di spazi aperti (logge, balconi, lastrici solari). Stessa cosa per i tetti verdi.
Obbligo di rastrelliere per bici oltre una certa soglia di intervento e colonnine elettriche (c’è già una legge nazionale, pochissimo applicata).
Nelle nostre case deve essere consentito fare più metri quadri per ospitare una stanza per il tele-lavoro e una stanza comune obbligatoria per i condominii oltre un certo numero di appartamenti. Probabilmente si può pensare a un affievolimento del Contributo di Costruzione per consentire queste superfici.
Sul recupero dell’acqua piovana ho grandi dubbi. In genere questi serbatoi sono vuoti in estate, quando servirebbero per innaffiare. D’inverno dovrebbero servire a smorzare l’onda di picco quando piove troppo e quindi le fognature vanno in crisi. Solo che d’inverno il serbatoio e pieno e il ritardo tra la pioggia e lo scarico in fogna è basso. Per alimentare una linea di adduzione interna per usi civili significa oggi avere un doppio impianto e trattare chimicamente l’acqua prima di metterla a disposizione. Finora non mi sono sembrati una soluzione particolarmente felice.
Una piccolissima digressione sull’urbanistica tattica (tactical urbanism). Io preferirei chiamarla agopuntura urbana, anche se non fa molta differenza: può aiutare a rendere più gradevole la città. Certo, anche qui non facciamoci troppe illusioni: se si chiama “tattica” e non “strategica”, c’è un motivo. Dipingere di rosa l’asfalto di un tratto di strada non lo fa diventare magicamente una piazza o un parco giochi. La qualità vera della città è fatta da elementi di qualità, solidi e affidabili.
Un ragionamento a parte va fatto per gli standard urbanistici. E’ un ragionamento che senza una legislazione regionale conforme lascia pochi spazi di manovra, anche se sufficienti in sede di PRG e in sede di regolamento edilizio, per fare qualche passo in più. Per semplificare, chi fa grandi interventi (lottizzazioni o costruzioni importanti), è obbligato dalla legge a lasciare degli spazi attrezzati come verde pubblico e a realizzare e cedere dei parcheggi pubblici. Quando questi spazi vengono ceduti al Comune, passa al Comune anche la manutenzione e la responsabilità. E’ di tutta evidenza che nel caso di superfici piuttosto piccole e lontane tra esse, il Comune spende molti soldi per la manutenzione negli anni. Allora bisognerebbe modulare in prima istanza la percentuale tra verde e parcheggi (nel quartiere Santa Lucia, per esempio, sarebbe molto più utile avere i parcheggi piuttosto che il verde). In secondo luogo lasciare al privato quanto più possibile queste piccole aree lasciando l’uso pubblico. Questi piccoli lembi di terreno (a volte poche decine di metri quadrati), costringono il Comune a un onere manutentivo esagerato rispetto all’utilità pubblica. Tutto ciò può essere ricalibrato attraverso il calcolo del Contributo di Costruzione (cosiddetta “Bucalossi”). E, visto che siamo in tema di oneri, andrebbe messo nel calcolo degli oneri, per i fabbricati produttivi, il rischio dell’eventuale costo di demolizione e bonifica del terreno. E’ successo infatti che alcune attività produttive falliscono e lasciano sul campo “il ferito” e cioè un fabbricato in stato di abbandono. Oltre a essere un vulnus sul territorio, essi rappresentano un ulteriore costo per chi compra, e quindi tutto ciò rallenta le operazioni di rigenerazione. Chi compra uno di questi fabbricati da demolire deve avere uno sconto sugli oneri, sconto pagato da chi ha costruito per primo.
Il verde, il ruolo dell’agricoltura
Chi pensa all’agricoltura oggi (parlo di pianificatori, tecnici e politici), la pensa con le lenti romantiche di un’agricoltura molto vicina alla natura, molto soft, molto lenta … La vera agricoltura, quella che sfama la maggior parte di noi è ben altra cosa. Trattori di grande potenza, agricoltura di precisione, elevata robotizzazione, trattamenti periodici, ecc. Non c’è nessun Mulino Bianco a fare dei buoni croissant: solo dei grandi molini con dei silos molto alti, che fanno molto rumore, che fanno molta polvere, che richiedono molti camion all’andata e al ritorno. E così via per i pomodori, per esempio e per rimanere ad un prodotto che per molti anni ha informato la vita e l’architettura di Bastia Umbra.
C’è un lato duro delle cose che non vogliamo vedere, ma che permane. Faccio un esempio.
Noi possiamo chiamare anche “mobilità dolce” una pista ciclabile, ma si tratta pur sempre di terreni da espropriare, di una costruzione da realizzare (e da mantenere nel tempo). Per una pista ordinaria da circa 3,50 m di larghezza parliamo di 350 euro/m lineare, più esproprio. Più la manutenzione negli anni. Dico questo perché a me piacciono le piste: costano meno di una strada ma costano. Un km di pista significa togliere dal bilancio 400.000 euro, solo per la realizzazione. Se si mettono tutti i costi di un Quadro Tecnico di un lavoro pubblico arriviamo facilmente a 600.000 euro. Il lato duro delle cose è anche prendere coscienza che i Comuni hanno sempre meno fondi nel loro bilancio. Le risorse che arrivano sono spesso a valle di linee di finanziamento speciali (PNRR), oppure agganciate a un progetto che deve essere cantierabile in tempi brevissimi. E qui il Comune sconta la difficoltà (leggasi: impossibilità di un progetto fatto all’interno), di doversi affidare all’esterno, con tempi ristrettissimi e con soldi (di parte corrente), che spesso non ha.
Noi possiamo anche dire “agricoltura urbana”. Ma non è quest’agricoltura che ci può sfamare. La maggior parte del grano che i grandi molini lavorano da queste parti vengono dall’Ucraina: è inutile pensare che la produzione locale soddisfi la domanda. Può essere agricoltura ortiva, decentralizzata, didattica, ludica, sociale, ma non intensiva. Agricoltura ornamentale o poco più. (A me piace l’ornamento: dico solo di non farci abbindolare da bellissimi render di grandi studi d’architettura: il grano in mezzo ai nuovi palazzi dell’Area Franchi non serve a nulla. Né a migliorare l’architettura né a portare il grano a Petrini a km zero.)
Il Parco Agricolo è un’invenzione lessicale bellissima, ma cosa ha prodotto oltre alla negazione della saldatura tra Santa Maria degli Angeli e Bastia? Il Parco Agricolo del Sistema Centrale è stato per Bastia Umbra un insediamento residenziale estensivo e Assisi lo ha sconfessato allo stesso modo. Io invece auspico la continuità tra le due realtà insediative esistenti, visto ormai il fascio infrastrutturale sedimentato tra le due città? Fascio infrastrutturale impossibile da smantellare, visti anche gli investimenti stratificati sull’asse, e impossibile da evitare. Questi varchi ecologici nord-sud di cui si parla spesso anche in sedi regionali, sono smentiti dalla realtà delle barriere antropiche costituite dalla ferrovia, dalla SS75, dalla Strada Regionale Umbra, da Via Roma. Senza veri corridoi ecologici (che non siano solo trappole a favore di alcune specie), non vi è, già da anni, nessuna continuità in direzione nord-sud. E anche in questo caso, dovrebbe essere una pianificazione di rango regionale a dire dove vanno lasciati dei grandi varchi, tra Foligno e Ponte San Giovanni, e non lasciato ai Comuni l’onere di trovare sul proprio territorio, un problema che si è posto con decisioni sovraccomunali.
Questi grandi varchi potrebbero forse essere pensati tra Rivotorto e il cimitero di Santa Maria degli Angeli oppure tra Villaggio XXV Aprile e Ospedalicchio o ancora tra Ospedalicchio e Collestrada. Solo chi ha una visione ideologica non riesce a vedere che già oggi quel verde tra Santa Maria e Bastia, confinato tra Via Roma la ferrovia e SS 75 non ha più senso.
Per restare ancora sul lato duro delle cose, il suolo destinato all’agricoltura intensiva non è un suolo naturale: pieno di concimi, ormoni e nitrati, zappato, fresato, irrigato, falciato ha più ben poco di naturale. E allora io lo vorrei considerare “consumo di suolo”, al pari del giardino di casa (che fa consumo, appunto). Sul consumo di suolo ci sarebbe molto da dire, come si vede, perché il fenomeno è più complesso del previsto. Per esempio il suolo naturale (per me uno dei pochi naturali), e cioè quello dei boschi e delle foreste, negli ultimi cento anni è raddoppiato in Italia, con un andamento leggermente iperbolico. E basta guardare le foto di inizio secolo per vedere come i nostri monti erano depredati e brulli. Ne abbiamo consumato. E ne abbiamo guadagnato.
La transizione ecologica, la transizione tecnologica
Ritengo che i tetti dei nostri fabbricati, soprattutto quelli industriali debbano trasformarsi in tetti verdi o in tetti fotovoltaici. I tetti verdi sui fabbricati industriali costano moltissimo: non possiamo farci troppe illusioni. Si possono fare, ovviamente, ma è un costo che va preventivato. Costano molto di più rispetto ad altri fabbricati perché le luci tra i pilastri sono molto più lunghi e dunque il peso in copertura fa aumentare i costi delle strutture in maniera più che proporzionale. Più logico e sostenibile pensare a pannelli fotovoltaici (en passant, così verrò sommerso dagli insulti: preferisco le pale eoliche alle sconfinate praterie di pannelli).
Non possiamo fare molto di più per passare a modalità energetiche più pulite. Potrei mentire e dire che se spengiamo le lampadine quando andiamo in un’altra stanza stiamo salvando il pianeta, ma non lo farò.
L’energia più pulita che possiamo avere è quella che non consumiamo. Dovremmo fare case più performanti, certo. Credo (altri insulti), che una delle modalità più intelligenti sia di fare case un po’ più grandi, con stanze di compensazione, con grande inerzia termica (o meglio: capacità termica). Tra venti anni dovremo rifare i nostri cappotti di polistirolo e mettere nuovi pannelli fotovoltaici. Queste cose hanno un costo e bisognerebbe fare un LCA (Life Cycle Assessment: un bilancio energetico completo, per semplificare), per rendersene conto.
La città dei 15 minuti è uno slogan che può andare bene per Parigi, ma che a Bastia Umbra non ha senso. Bastia ha un territorio di circa 5 km di diametro. In bicicletta è già a dimensione del quarto d’ora. Nelle sue frazioni tutto il necessario è raggiungibile in 15 minuti a piedi.
La forma della città è ormai irrecuperabile, o meglio è una forma che non si riesce più a identificare in una forma chiusa. La città è dispersa. E’ un male? Sì certo. Ma oggi, con i droni, la mobilità individuale a basso impatto, la possibilità di un’edificazione off-grid, come obbligare i cittadini (noi), a limitarsi, a restare all’interno di un confine? E quale confine, oggi? Quali nudge mettere in campo per ri-orientare tutta una politica insediativa?
La tecnologia decentralizza tutti i servizi, che arrivano nelle nostre case o ancora meglio sui nostri telefonini. Certificati, pagamenti, salute (tele-medicina), educazione, formazione, ecc. Oggi non c’è servizio che non possa essere dematerializzato. Questo ha un effetto enorme sulla città. Il telelavoro del covid ha già imposto strategie immobiliari di adeguamento ai grandi gruppi di servizi, nelle grandi città. E’ questione di tempo, ma anche tutto il settore pubblico si sposterà verso un mix di lavoro in presenza e lavoro da remoto. E dunque bisogna inventarsi delle nuove forme di aggregazione. Probabilmente diminuiscono i grandi complessi per i servizi e aumenteranno gli spazi per palestre, gioco, shopping (di un certo tipo). Ci vedremo meno per lavorare: ci vedremo di più per divertirci, per fare sport, per mostrare empatia, per curare, per incontrarsi e basta. Si badi bene: tutte cose che saranno virtualizzate anch’esse, e quindi la presenza fisica sarà una scelta in più, e non un obbligo. Tra i luoghi fisici che vedo con un certo futuro ancora davanti penso alla piazza (la nostra migliore invenzione), e poi palestre (con un ampliamento concettuale verso una sport-city), e i luoghi di cura. E poi, con formula fortunata, in non luoghi: aeroporti, centri di scambio intermodali, stazioni ferroviarie.
Sulla partecipazione e la felicità (una ripresa)
Riprendo il tema, anche se è leggermente fuori sede, solo perché mi è stato chiesto da più parti.
Per parlare subito chiaro, non sono un grande fan della partecipazione. Mi si dirà “Per forza, non l’hai mai vista fatta bene …” Può darsi, anche se lo studio che ha curato questa parte a Bastia Umbra, per conto di Federico Oliva, non è l’ultimo arrivato.
Né le altre partecipazioni a cui ho assistito per CQ3 in Umbria, o per qualche PRG, mi ha ancora convinto. Né i PRG o le grandi rigenerazioni che seguo da lontano e che sono state oggetto di partecipazione mi sembrano eclatanti. Mi sembra che il valore aggiunto della partecipazione, rispetto al progetto uscito, sia modestissimo.
Non sono un grande fan perché ho anche paura che architetti e politici deleghino (rectius: scarichino), ad altri soggetti non solo la profondità dell’analisi, ma addirittura le soluzioni. E questo è un modo facile per “svignarsela” dalle responsabilità politiche e dalle responsabilità politiche. Ed evitare la fatica dello studio continuo (per i professionisti), e dell’ascolto continuo, in mezzo alla gente (per i politici).
Sulla felicità. E’ una questione molto prosaica, se si vuole. Il PRG riguarda la totalità del territorio comunale e quindi (almeno), tutti i suoi cittadini. Pianificare bene la risorsa spazio è una delle condizioni che aiuta a rendere felici le persone: seduto sotto un “pronao” della Rotonda del Palladio sto bene: seduto al casello autostradale di Roma Nord non sto bene. Gli esempi sarebbero troppo facili e non ne farò più.
Fino a qualche tempo fa il PRG poteva essere una questione di vocali (come dico sempre scherzando), e si poteva trasformare in Piano Regalatore Generale, rendendo molto felici alcuni e pochissimo felici altri. Oggi, teoricamente, la pianificazione ha introiettato e digerito la cultura della perequazione. Controfattualmente, tuttavia, anche la perequazione non ha sortito tutti questi effetti. La perequazione generalizzata su tutto il territorio comunale non esiste (in termini statistici significativi), e quella endo-ambito, beh, c’è sempre stata: si è mai visto un Piano di Lottizzazione in cui un proprietario di un piccolo fondo si prendeva tutta l’edificabilità e un altro nulla? Diciamo quindi che oggi c’è una maggiore attenzione a questi aspetti, quando si pianifica, che è già un risultato positivo. All’interno di un comparto, di una zona, di un ambito (chiamiamolo come vogliamo), o il sistema è perequato o è bloccato.
Tornando alla felicità: il PRG interessa tutti, e in piccola parte contribuisce alla felicità dei cittadini. “L’ordinato assetto del territorio” non è altro che la formulazione giuridica di una cosa che interessa tutti e che se c’è ci rende tutti un po’ più felici.
La partecipazione può essere fatta a più livelli e io credo che ai livelli generali abbia poco senso, mentre a livello locale (sul come rendiamo questa scuola più gradevole), possa avere un’utilità.
La partecipazione rischia spesso di trasformarsi in un lunghissimo cahier de doléances e/o in un grande libro dei sogni. Giustamente credo io: non si può chiedere a un cittadino qualsiasi di farsi carico della complessità del montaggio di un’operazione di rigenerazione urbana. Non tutte le scelte possono (o devono), essere condivise con tutti prima di farle. Non è possibile fare un referendum, su tutto, con il probabile risultato di rinviare comunque i fatti a un momento decisivo: la scelta, la decisione. Che scontenterà necessariamente qualcuno. Un equilibrio statico della felicità per tutti è impossibile.
Certo, vi è una certa felicità nel sapere di aver contribuito e partecipato a una soluzione. Ma non vorrei che fosse sovrastimata.
Né qui voglio parlare della partecipazione come nuova forma di autogoverno dal basso, dalla democrazia rappresentativa alla democrazia partecipativa, perché a mio avviso esula da questo scritto e anche dalla formazione del PRG.
Se ci si crede, occorre creare un modello che funzioni indipendentemente dal PRG e poi applicarlo, e non prendere il PRG come luogo di coltura in vitro o cavia da esperimento. E lo stesso vale per il baratto amministrativo, i beni comuni, ecc. Si parta da piccole cose, si faccia funzionare il meccanismo e poi si cresca di livello, se funziona.
Un ultimo contributo sul tema: formalizzare la costituzione di un “pensamento” (il parlamento essendo il luogo in cui si parla). Questo pensamento, un think tank per i moderni, potrebbe essere costituito da un raggruppamento di 10-15 soggetti che pensano continuamente alla città: la osservano, la studiano, e producono idee a livello pre-tecnico. Questo pensamento non ha ovviamente colore politico ma è solo d’ausilio alla Giunta Comunale e al Consiglio, in quanto deve produrre un documento, o una serie di documenti, o eventi, utili alla successiva scelta politica. La cabina di regìa sarebbe affidata al Comune (al Sindaco o suo delegato), e lo stesso Comune potrebbe mettere a disposizione un luogo dove riunirsi. In via del tutto indicativa e aurorale, potrebbero chiamarsi al tavolo (un rappresentante per ogni categoria): l’Università, i commercianti, gli agricoltori, le aziende, i professionisti, il mondo dello sport, la scuola. Qualcuno potrebbe definirla come una forma di partecipazione “ben temperata”.